 Se
i Celti hanno, per molti versi, dato forma al primo nucleo di cultura
europeo degno di questo nome, quando parliamo di popolazioni
barbariche il primo nome che quasi certamente ci viene in mente è
quello dei Germani. Tutta la storiografia latina, da Cesare a Tacito e
Svetonio, ci parla di loro e, normalmente, pur non nascondendo una
certa stima per la loro forze ed il loro coraggio, nessun autore usa
un tono davvero elogiativo per quelli che, in qualche modo, erano i
nemici per eccellenza dell'Impero (anche se questi “nemici”, in
realtà, diventeranno gli ultimi difensori del “Limes Imperii”).
Come sempre accade, una versione piuttosto acritica e popolarizzata di
descrizioni già di per sé volutamente parziali, ha fatto sì che
nell'immaginario comune i Germani diventassero guerrieri feroci,
rozzi, ignoranti e sanguinari: sostanzialmente, appunto, il classico
paradigma del barbaro. Ma chi erano realmente i Germani? Da dove
venivano? Perché un popolo considerato, in fin dei conti, rozzo e
arretrato divenne il pericolo fatale per il più grande impero del
mondo antico? Proviamo a seguire le tracce della loro evoluzione per
cercare di trovare risposta a questi quesiti. Se
i Celti hanno, per molti versi, dato forma al primo nucleo di cultura
europeo degno di questo nome, quando parliamo di popolazioni
barbariche il primo nome che quasi certamente ci viene in mente è
quello dei Germani. Tutta la storiografia latina, da Cesare a Tacito e
Svetonio, ci parla di loro e, normalmente, pur non nascondendo una
certa stima per la loro forze ed il loro coraggio, nessun autore usa
un tono davvero elogiativo per quelli che, in qualche modo, erano i
nemici per eccellenza dell'Impero (anche se questi “nemici”, in
realtà, diventeranno gli ultimi difensori del “Limes Imperii”).
Come sempre accade, una versione piuttosto acritica e popolarizzata di
descrizioni già di per sé volutamente parziali, ha fatto sì che
nell'immaginario comune i Germani diventassero guerrieri feroci,
rozzi, ignoranti e sanguinari: sostanzialmente, appunto, il classico
paradigma del barbaro. Ma chi erano realmente i Germani? Da dove
venivano? Perché un popolo considerato, in fin dei conti, rozzo e
arretrato divenne il pericolo fatale per il più grande impero del
mondo antico? Proviamo a seguire le tracce della loro evoluzione per
cercare di trovare risposta a questi quesiti.
Sostanzialmente, i Germani erano genti di
ceppo indoeuropeo, originarie del nord Europa (o almeno certamente
stanziali in aree baltico-scandinave in un periodo molto antico del
loro percorso migratorio da oriente) e identificate dall'utilizzo di
lingue derivanti da una origine unica, definita “Germanico
Comune”, diversificatasi solo durante l'età del ferro (1).
Il termine Germani, con cui oggi conosciamo
questo insieme di nazioni diverse unite da una origine comune, è
ovviamente latino, ma è alquanto difficile comprendere da quale
etimologia derivi. Di per sé “germanus” può significare
“parente”, “simile” o “autentico”. Strabone ci dice che i
Romani definirono così quelli che ritenevano essere gli “autentici
Galli” ma sembra più probabile che il termine derivi dal fatto che
i Germani erano visti come “simili”, “apparentati” ai Galli
stessi. Certamente, comunque, il termine doveva essere molto antico,
visto che lo troviamo già in una iscrizione dei Fasti Capitolini
datata 222 a.C. (“DE GALLEIS INSUBRIBUS ET GERM.”) e,
successivamente, in uno scritto di Poseidonio del 80 a.C., ma è solo
con Cesare che diventa di uso consuetudinario, perdendo l'accezione
originale per divenire connotativo di un popolo che, di per sé,
neppure aveva un endonimo auto-designativo. I Germani, infatti,
chiamavano tutti coloro che sentivano come diversi da loro “walha”
(da cui oggi Welsh – Gallese; Walloon – Vallone, ecc.)  ma
definivano sé stessi unicamente come “ þiuda”, gente (2).
Anche la divisione di queste "genti" in Germani Occidentali
(da cui poi Visigoti), Germani Orientali (da cui Ostrogoti) e Germani
Settentrionali (da cui, in epoca ancora successiva, Normanni) è solo
una classificazione linguistica moderna: i Greci dividevano tutti i
barbari settentrionali unicamente in Celti e Sciti e solo a partire
dal I e II secolo alcuni etnografi (Tacito, Plinio il Vecchio,
Tolomeo, Strabone) cominciano a classificare questo gruppo
fondamentalmente indistinto in nazioni e tribù (Strabone ne censirà
40 e Tolomeo addirittura 69) sulla base di dialetti e usanze proprie,
innestate, comunque, su un substrato culturale comune (3).
Alcuni di quegli stessi nomi individuati dagli etnografi per indicare
popolazioni stanziali tra Oder e Vistola (Goti, Vandali) riappariranno
nel III secolo per indicare popolazioni situate tra basso Danubio e
Carpazi, ma è solo nel V secolo che una sorta di mappa dei Germani e
dei loro stanziamenti si comincia a delineare compiutamente, con i
Goti in Gallia, Iberia e Italia, i Vandali in Africa, i Gepiti lungo
il Danubio e, più a est Rugi, Sciri, Burgundi e molti altri (tra cui,
piuttosto curiosamente, sono inclusi gli Alani, una popolazione in
realtà iranica, quasi sempre però ritenuta germanica dalla
storiografia romana). ma
definivano sé stessi unicamente come “ þiuda”, gente (2).
Anche la divisione di queste "genti" in Germani Occidentali
(da cui poi Visigoti), Germani Orientali (da cui Ostrogoti) e Germani
Settentrionali (da cui, in epoca ancora successiva, Normanni) è solo
una classificazione linguistica moderna: i Greci dividevano tutti i
barbari settentrionali unicamente in Celti e Sciti e solo a partire
dal I e II secolo alcuni etnografi (Tacito, Plinio il Vecchio,
Tolomeo, Strabone) cominciano a classificare questo gruppo
fondamentalmente indistinto in nazioni e tribù (Strabone ne censirà
40 e Tolomeo addirittura 69) sulla base di dialetti e usanze proprie,
innestate, comunque, su un substrato culturale comune (3).
Alcuni di quegli stessi nomi individuati dagli etnografi per indicare
popolazioni stanziali tra Oder e Vistola (Goti, Vandali) riappariranno
nel III secolo per indicare popolazioni situate tra basso Danubio e
Carpazi, ma è solo nel V secolo che una sorta di mappa dei Germani e
dei loro stanziamenti si comincia a delineare compiutamente, con i
Goti in Gallia, Iberia e Italia, i Vandali in Africa, i Gepiti lungo
il Danubio e, più a est Rugi, Sciri, Burgundi e molti altri (tra cui,
piuttosto curiosamente, sono inclusi gli Alani, una popolazione in
realtà iranica, quasi sempre però ritenuta germanica dalla
storiografia romana).
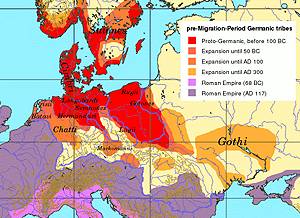 Seguire
il cammino degli spostamenti dei Germani in Europa non è impresa
semplice, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente al
loro contatto con Roma. Si è detto che la loro origine prima (almeno
per quanto riguarda le nostre conoscenze) è situabile nella zona
baltica occidentale. Questa nozione ci è fornita essenzialmente dalla
genetica storica che ha individuato nei resti di guerrieri germanici
un gene (tecnicamente l'Aplogruppo I1a) presente oggi unicamente negli
abitanti della Scandinavia meridionale e nella Danimarca
settentrionale (4).
L'area così delineata, chiamata area della Cultura dell'Età del
Bronzo Settentrionale, ha, comunque, fornito riprove
storico-archeologiche di un intenso insediamento umano risalente al
periodo compreso tra 1700 a.C. e 600 a.C. , facendo pensare che
proprio in questo ampio lasso di tempo si sia compiuta, sulla base
dell'individuazione di un sistema espressivo-comunicativo coeso e
distinto, la diversificazione tra Proto-Indoeuropei e Proto-Germanici.
Sempre a questo periodo dovrebbero risalire le prime migrazioni di
massa da questa zona di (para-)origine. Le cause vanno cercate
probabilmente nell'incontro con alcune culture nomadiche preistoriche
(Hügelgräber, Urnfield, La Tene) e, soprattutto, in un progressivo
peggioramento della situazione climatica peri-baltica che,
inizialmente tra 850 e 760 a.C. e poi più sostanzialmente dopo il 650
a.C., avrebbe spinto i proto-Germani verso le coste della Germania
Orientale, verso la Vistola e, in misura minore, verso sud ovest. Si
tratta di migrazioni di fondamentale importanza non solo perché
determinano il sistema culturale solo semi-stanziale che caratterizzerà
tutta la storia germanica, ma anche perché permetteranno l'incontro
dei proto-Germani con la cultura di Hallstatt (in espansione verso
nord), sviluppando una intersezione culturale germano-celtica che
permeterà ai germani di entrare nell'età del ferro (5).
Di fatto, comunque, già intorno al 700 a.C. l'area germanica
comprendeva un vasto arco che andava dall'odierna costa olandese alla
Vistola, in una situazione che, per circa 400 anni, avrebbe visto una
parziale stanzializzazione delle popolazioni germaniche. Cosa accadde
poi, intorno al 300 a.C., per portare i Germani a sviluppare un nuovo
assetto nomadico? In realtà nulla più che un normale processo
storico-demografico: trovandosi in una situazione territoriale più
favorevole i Germani cominciarono a moltiplicarsi, determinando un
incremento demografico notevole e, conseguentemente, un progressivo
impoverimento di terre sempre più estensivamente ed intensivamente
coltivate. Fu, dunque, una probabile crisi alimentare che spinse i
Germani verso sud, cosicché, intorno al 250 a.C. possiamo individuare
già almeno cinque diversi gruppi di ri-stanziamento (corrispondenti,
ovviamente, a cinque differenziazioni linguistiche successive):
Nord-Germani nella Scandinavia meridionale, Nord-Germani marittimi
lungo il Mare del Nord, Germano-Renani tra Reno e Wesser,
Germani-Elbici, lungo l'Elba e Germano-Orientali tra Oder e Vistola. A
questo punto, i contatti tra Germani e Celti diventano fittissimi
(probabilmente con una sorta di protettorato celtico sui territori
germanici, almeno ad occidente, anche se la situazione è tutt'altro
che chiara), tanto che non è affatto infrequente rinvenire sepolture
in cui siano presenti oggetti di fattura sia celtica che germanica.
Questa sorta di mescolamento (che, comunque, non fu mai totale), fa sì
che sia difficile stabilire in che misura i primi Germani che troviamo
nella storiografia latina siano effettivamente Germani o Celti o,
forse, una mescolanza delle due popolazioni (6).
In effetti, la tradizionale divisione territoriale romana tra le due
popolazioni, con un confine intercorrente lungo il Reno, è solo
funzionale alla politica di Roma, ma appare tutt'altro che precisa,
alla luce sia dei ritrovamenti archeologici, sia di imprecisioni
storiografiche di notevole Seguire
il cammino degli spostamenti dei Germani in Europa non è impresa
semplice, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente al
loro contatto con Roma. Si è detto che la loro origine prima (almeno
per quanto riguarda le nostre conoscenze) è situabile nella zona
baltica occidentale. Questa nozione ci è fornita essenzialmente dalla
genetica storica che ha individuato nei resti di guerrieri germanici
un gene (tecnicamente l'Aplogruppo I1a) presente oggi unicamente negli
abitanti della Scandinavia meridionale e nella Danimarca
settentrionale (4).
L'area così delineata, chiamata area della Cultura dell'Età del
Bronzo Settentrionale, ha, comunque, fornito riprove
storico-archeologiche di un intenso insediamento umano risalente al
periodo compreso tra 1700 a.C. e 600 a.C. , facendo pensare che
proprio in questo ampio lasso di tempo si sia compiuta, sulla base
dell'individuazione di un sistema espressivo-comunicativo coeso e
distinto, la diversificazione tra Proto-Indoeuropei e Proto-Germanici.
Sempre a questo periodo dovrebbero risalire le prime migrazioni di
massa da questa zona di (para-)origine. Le cause vanno cercate
probabilmente nell'incontro con alcune culture nomadiche preistoriche
(Hügelgräber, Urnfield, La Tene) e, soprattutto, in un progressivo
peggioramento della situazione climatica peri-baltica che,
inizialmente tra 850 e 760 a.C. e poi più sostanzialmente dopo il 650
a.C., avrebbe spinto i proto-Germani verso le coste della Germania
Orientale, verso la Vistola e, in misura minore, verso sud ovest. Si
tratta di migrazioni di fondamentale importanza non solo perché
determinano il sistema culturale solo semi-stanziale che caratterizzerà
tutta la storia germanica, ma anche perché permetteranno l'incontro
dei proto-Germani con la cultura di Hallstatt (in espansione verso
nord), sviluppando una intersezione culturale germano-celtica che
permeterà ai germani di entrare nell'età del ferro (5).
Di fatto, comunque, già intorno al 700 a.C. l'area germanica
comprendeva un vasto arco che andava dall'odierna costa olandese alla
Vistola, in una situazione che, per circa 400 anni, avrebbe visto una
parziale stanzializzazione delle popolazioni germaniche. Cosa accadde
poi, intorno al 300 a.C., per portare i Germani a sviluppare un nuovo
assetto nomadico? In realtà nulla più che un normale processo
storico-demografico: trovandosi in una situazione territoriale più
favorevole i Germani cominciarono a moltiplicarsi, determinando un
incremento demografico notevole e, conseguentemente, un progressivo
impoverimento di terre sempre più estensivamente ed intensivamente
coltivate. Fu, dunque, una probabile crisi alimentare che spinse i
Germani verso sud, cosicché, intorno al 250 a.C. possiamo individuare
già almeno cinque diversi gruppi di ri-stanziamento (corrispondenti,
ovviamente, a cinque differenziazioni linguistiche successive):
Nord-Germani nella Scandinavia meridionale, Nord-Germani marittimi
lungo il Mare del Nord, Germano-Renani tra Reno e Wesser,
Germani-Elbici, lungo l'Elba e Germano-Orientali tra Oder e Vistola. A
questo punto, i contatti tra Germani e Celti diventano fittissimi
(probabilmente con una sorta di protettorato celtico sui territori
germanici, almeno ad occidente, anche se la situazione è tutt'altro
che chiara), tanto che non è affatto infrequente rinvenire sepolture
in cui siano presenti oggetti di fattura sia celtica che germanica.
Questa sorta di mescolamento (che, comunque, non fu mai totale), fa sì
che sia difficile stabilire in che misura i primi Germani che troviamo
nella storiografia latina siano effettivamente Germani o Celti o,
forse, una mescolanza delle due popolazioni (6).
In effetti, la tradizionale divisione territoriale romana tra le due
popolazioni, con un confine intercorrente lungo il Reno, è solo
funzionale alla politica di Roma, ma appare tutt'altro che precisa,
alla luce sia dei ritrovamenti archeologici, sia di imprecisioni
storiografiche di notevole  portata.
Quando, ad esempio, Cesare parla di Eburoni come di una popolazione
germanica compie un errore marchiano, dal momento che gli Eburoni, sia
per il nome stesso, sia per i ritrovamenti archeologici successivi,
erano chiaramente Celti, né sembra in alcun modo probabile che, come
afferma Tacito, essi avessero subito una determinante penetrazione
Batava. Questi elementi rendono estremamente complesso determinare
quale fosse l'effettiva area di stanziamento germanica al momento del
contatto con Roma, anche se possiamo con sicurezza affermare che,
verso il 100 a.C l'intera area sub-baltica poteva essere considerata
completamente germanizzata (7). portata.
Quando, ad esempio, Cesare parla di Eburoni come di una popolazione
germanica compie un errore marchiano, dal momento che gli Eburoni, sia
per il nome stesso, sia per i ritrovamenti archeologici successivi,
erano chiaramente Celti, né sembra in alcun modo probabile che, come
afferma Tacito, essi avessero subito una determinante penetrazione
Batava. Questi elementi rendono estremamente complesso determinare
quale fosse l'effettiva area di stanziamento germanica al momento del
contatto con Roma, anche se possiamo con sicurezza affermare che,
verso il 100 a.C l'intera area sub-baltica poteva essere considerata
completamente germanizzata (7).
Questo discorso sulla storiografia latina ci
porta al grande capitolo dell'incontro-scontro tra Germani e Romani,
che affronteremo nella seconda parte di questa ricerca. Prima di
affrontarlo, però, è il caso di dare una rapida scorsa al sistema
culturale germanico al momento dell'incontro con le legioni di Roma.
- LIBERTA',
DEMOCRAZIA E MISTICA
 Si
è già detto di un substrato linguistico comune tra tutte le
tribù e nazioni. Purtroppo, non esistendo tra i Germani
alcuna tradizione scritta fino al V secolo, non possiamo in
alcun modo oggi delineare il percorso di differenziazione di
tale ceppo comune e possiamo solo affermare con certezza che
già appunto nel V secolo tale differenziazione era tale da
non permettere alcun interscambio comunicativo tra gruppi
linguistici differenti. E' altamente probabile che un processo
analogo sia avvenuto anche per quanto riguarda gli aspetti
sociali, culturali e religiosi, che da alcune fonti letterarie
più tarde come il Beowulf o la Saga Volsunga, sappiamo aver
mantenuto, comunque, elementi di base comuni nella maggior
parte delle tribù (8). Si
è già detto di un substrato linguistico comune tra tutte le
tribù e nazioni. Purtroppo, non esistendo tra i Germani
alcuna tradizione scritta fino al V secolo, non possiamo in
alcun modo oggi delineare il percorso di differenziazione di
tale ceppo comune e possiamo solo affermare con certezza che
già appunto nel V secolo tale differenziazione era tale da
non permettere alcun interscambio comunicativo tra gruppi
linguistici differenti. E' altamente probabile che un processo
analogo sia avvenuto anche per quanto riguarda gli aspetti
sociali, culturali e religiosi, che da alcune fonti letterarie
più tarde come il Beowulf o la Saga Volsunga, sappiamo aver
mantenuto, comunque, elementi di base comuni nella maggior
parte delle tribù (8).
 Cercando
di trarre i minimi comun denominatori dai dati storici in
nostro possesso, possiamo dire che la struttura sociale
fondamentale della società germanica fosse data dalla Sippe,
una sorta di unione di famiglie legate da vincoli parentali,
che costituiva una unità politico-economica e militare
totalmente autosufficiente. Ben più labile era, invece il
concetto di tribù, o gau: solo in caso di necessità essa si
riconosceva come unità, al comando di una assemblea dei vari
capi-sippe. Questo elemento ci introduce nel vasto argomento
della struttura politica germanica. I concetti base per ogni
uomo libero erano quelli di libertà individuale e, per quanto
possa apparirci strano oggi, di democrazia (9).
Ciò portava a forme di “controllo statale” tanto leggere
da risultare pressoché inesistenti e ad una sostanziale
collegialità di ogni decisione: il governo di una tribù era
affidato all'assemblea dei liberi (allthing), che esprimeva le
decisioni del popolo e che solo in caso di guerra eleggeva a
maggioranza un capopopolo, la cui autorità era, almeno fino
al periodo immediatamente precedente ai regni
romano-barbarici, solo temporanea e, comunque, mai disgiunta
dalla concezione di “primus inter pares”. Cercando
di trarre i minimi comun denominatori dai dati storici in
nostro possesso, possiamo dire che la struttura sociale
fondamentale della società germanica fosse data dalla Sippe,
una sorta di unione di famiglie legate da vincoli parentali,
che costituiva una unità politico-economica e militare
totalmente autosufficiente. Ben più labile era, invece il
concetto di tribù, o gau: solo in caso di necessità essa si
riconosceva come unità, al comando di una assemblea dei vari
capi-sippe. Questo elemento ci introduce nel vasto argomento
della struttura politica germanica. I concetti base per ogni
uomo libero erano quelli di libertà individuale e, per quanto
possa apparirci strano oggi, di democrazia (9).
Ciò portava a forme di “controllo statale” tanto leggere
da risultare pressoché inesistenti e ad una sostanziale
collegialità di ogni decisione: il governo di una tribù era
affidato all'assemblea dei liberi (allthing), che esprimeva le
decisioni del popolo e che solo in caso di guerra eleggeva a
maggioranza un capopopolo, la cui autorità era, almeno fino
al periodo immediatamente precedente ai regni
romano-barbarici, solo temporanea e, comunque, mai disgiunta
dalla concezione di “primus inter pares”.  Naturalmente
non è il caso di enfatizzare all'eccesso questa
“democrazia” germanica: gli uomini liberi, i soli con il
diritto di possedere armi, erano comunque una minoranza quasi
oligarchica, al di sotto dalla quale si ponevano gli haldii,
uomini semiliberi il cui status era molto prossimo a quello
dei servi della gleba, e gli schiavi, numerosissimi e quasi
sempre prigionieri di guerra o civili catturati durante le
razzie. Va però notato che all'interno di quasi tutti i
gruppi tribali vigeva l'istituto del "comitatus",
cioè l'abitudine di aggregare i giovani di più bassa
estrazione sociale a quelli delle famiglie più importanti,
facendoli diventare compagni inseparabili in pace e in guerra
(in un modello di fedeltà personale che, in periodo
alto-medioevale, allo svilupparsi di figure reali all'interno
dei vari popoli germanici, arrivò ad influenzare numerose
istituzioni statali, divenendone anzi una delle
caratteristiche salienti) (10). Naturalmente
non è il caso di enfatizzare all'eccesso questa
“democrazia” germanica: gli uomini liberi, i soli con il
diritto di possedere armi, erano comunque una minoranza quasi
oligarchica, al di sotto dalla quale si ponevano gli haldii,
uomini semiliberi il cui status era molto prossimo a quello
dei servi della gleba, e gli schiavi, numerosissimi e quasi
sempre prigionieri di guerra o civili catturati durante le
razzie. Va però notato che all'interno di quasi tutti i
gruppi tribali vigeva l'istituto del "comitatus",
cioè l'abitudine di aggregare i giovani di più bassa
estrazione sociale a quelli delle famiglie più importanti,
facendoli diventare compagni inseparabili in pace e in guerra
(in un modello di fedeltà personale che, in periodo
alto-medioevale, allo svilupparsi di figure reali all'interno
dei vari popoli germanici, arrivò ad influenzare numerose
istituzioni statali, divenendone anzi una delle
caratteristiche salienti) (10).
All'alba del periodo imperiale,
comunque, i germani vivevano in piccole comunità formate da
costruzioni lignee molto semplici, anche se non mancavano aree
fortificate (i cosiddetti burga, da cui poi il suffisso -burg
tedesco e -bury inglese per indicare i villaggi). La proprietà
privata della terra era totalmente sconosciuta e le terre
venivano spartite tra i clan, che provvedevano, a loro volta,
a suddividere la loro quote tra le varie famiglie che che li
componevano. L'agricoltura del resto era molto primitiva e
tendente allo sfruttamento immediato del terreno strappato
alla foresta.
Così come il sistema socio-politico,
anche le abitudini erano molto semplici: i Germani, benché
alcune tribù più evolute producessero anche abiti di lana,
vestivano in linea di massima solo un gonnellino di pelle
animale o pantaloni (pur abitando in regioni molto fredde,
infatti, i Germani avevano l'abitudine di non portare molti
indumenti, a parte pelli tanto piccole da lasciare scoperte
gran parte del loro corpo), mentre solo i capi potevano
indossare una tunica sagomata con le maniche lunghe (11).
 Se
il sistema di vita dei Germani era fondamentalmente molto
lineare, non così era il loro sistema di pensiero, espresso
sostanzialmente nella loro filosofia religiosa. Oggi per noi
è molto difficile riuscire a ricostruire tale pensiero, sia
per l'estrema esiguità delle fonti scritte (comunque molto
tarde), sia per la loro difficoltà di interpretazione (sia
per quanto riguarda le rune che i poemi), per cui la nostra
conoscenza si basa quasi unicamente sulla successiva eredità
culturale vichinga. E', comunque, immediatamente riconoscibile
una derivazione molto precisa dal nucleo indo-europeo da cui i
Germani si staccarono: Asi e Vani, le due grandi “famiglie
divine”, ricordano da vicino gli Asura e i Deva indoiranici,
mentre le Norme, le filatrici del destino umano, ricordano le
Parche/Moire greco-romane. Curiosamente, proprio per questa
radice comune, le divinità germaniche sono altamente Se
il sistema di vita dei Germani era fondamentalmente molto
lineare, non così era il loro sistema di pensiero, espresso
sostanzialmente nella loro filosofia religiosa. Oggi per noi
è molto difficile riuscire a ricostruire tale pensiero, sia
per l'estrema esiguità delle fonti scritte (comunque molto
tarde), sia per la loro difficoltà di interpretazione (sia
per quanto riguarda le rune che i poemi), per cui la nostra
conoscenza si basa quasi unicamente sulla successiva eredità
culturale vichinga. E', comunque, immediatamente riconoscibile
una derivazione molto precisa dal nucleo indo-europeo da cui i
Germani si staccarono: Asi e Vani, le due grandi “famiglie
divine”, ricordano da vicino gli Asura e i Deva indoiranici,
mentre le Norme, le filatrici del destino umano, ricordano le
Parche/Moire greco-romane. Curiosamente, proprio per questa
radice comune, le divinità germaniche sono altamente 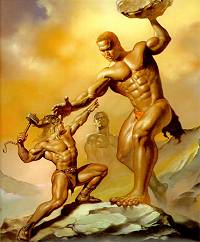 assimilabili
a quelle romane: Odino-Wotan, in quanto divinità che presiede
al passaggio tra vita e morte e divinità della conoscenza, è,
ad esempio, assimilabile a Hermes/Mercurio, mentre Thor è
simile a Ares/Marte (12).
Questi culti antichissimi, comunque, si erano andati fondendo
con altri elementi autoctoni delle varie aree di passaggio
delle tribù o con altri elementi ancora più antichi:
numerosi aspetti dei Vani sono ascrivibili al culto della
Terra/Madre e della fecondità ed è innegabile che le
popolazioni germaniche adorassero in prevalenza alcuni
elementi naturali, soprattutto alberi e boschi. In questo
senso si può leggere la presenza nell'Edda, una
raccolta poetica in lingua norrena del XIII secolo, dove però
si trovano ancora molti elementi del mondo pagano antico, la
figura dello Yggdrasil, l'albero sacro per eccellenza: la
sospensione a questo frassino sacro faceva parte, secondo il
poema, dell'iniziazione di Odino per acquisire il potere di
leggere le rune e, tra l'altro, la similitudine tra albero
sacro e Croce di Gesù fu usata dai missionari cristiani tra
l'VIII e X secolo per convertire i popoli germanici in Europa
centro-settentrionale. Anche un altro elemento della
religiosità germanica, forse il più interessante e
significativo di un sistema di pensiero tutt'altro che rozzo e
semplicistico, si prestò grandemente alla conversione alla
nuova religione del “Cristo bianco” per la sua somiglianza
con l'Apocalisse di Giovanni : il Ragnarök, cioè quella
apocalissi finale in cui, quasi a segnalare filosoficamente
l'ineluttabilità della caducità di ogni cosa, gli Asi, in
una battaglia campale, sarebbero caduti e tutto il mondo
sarebbe stato inghiottito dal lupo Fenrir. Forse proprio
queste analogie possono spiegare le ragioni della conversione,
in definitiva piuttosto rapida, al cristianesimo di una
popolazione che, fino a quel momento, come frutto estremo del
concetto egualitario che la caratterizzava, non aveva mai
avuto alcuna casta sacerdotale (anche se esistevano sciamani
dotati di particolari poteri che permettevano loro di mediare
tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, intesi sia come
entità divine che demoniache), né effigi religiose, né
santuari, né luoghi sacri costruiti dall'uomo (13). assimilabili
a quelle romane: Odino-Wotan, in quanto divinità che presiede
al passaggio tra vita e morte e divinità della conoscenza, è,
ad esempio, assimilabile a Hermes/Mercurio, mentre Thor è
simile a Ares/Marte (12).
Questi culti antichissimi, comunque, si erano andati fondendo
con altri elementi autoctoni delle varie aree di passaggio
delle tribù o con altri elementi ancora più antichi:
numerosi aspetti dei Vani sono ascrivibili al culto della
Terra/Madre e della fecondità ed è innegabile che le
popolazioni germaniche adorassero in prevalenza alcuni
elementi naturali, soprattutto alberi e boschi. In questo
senso si può leggere la presenza nell'Edda, una
raccolta poetica in lingua norrena del XIII secolo, dove però
si trovano ancora molti elementi del mondo pagano antico, la
figura dello Yggdrasil, l'albero sacro per eccellenza: la
sospensione a questo frassino sacro faceva parte, secondo il
poema, dell'iniziazione di Odino per acquisire il potere di
leggere le rune e, tra l'altro, la similitudine tra albero
sacro e Croce di Gesù fu usata dai missionari cristiani tra
l'VIII e X secolo per convertire i popoli germanici in Europa
centro-settentrionale. Anche un altro elemento della
religiosità germanica, forse il più interessante e
significativo di un sistema di pensiero tutt'altro che rozzo e
semplicistico, si prestò grandemente alla conversione alla
nuova religione del “Cristo bianco” per la sua somiglianza
con l'Apocalisse di Giovanni : il Ragnarök, cioè quella
apocalissi finale in cui, quasi a segnalare filosoficamente
l'ineluttabilità della caducità di ogni cosa, gli Asi, in
una battaglia campale, sarebbero caduti e tutto il mondo
sarebbe stato inghiottito dal lupo Fenrir. Forse proprio
queste analogie possono spiegare le ragioni della conversione,
in definitiva piuttosto rapida, al cristianesimo di una
popolazione che, fino a quel momento, come frutto estremo del
concetto egualitario che la caratterizzava, non aveva mai
avuto alcuna casta sacerdotale (anche se esistevano sciamani
dotati di particolari poteri che permettevano loro di mediare
tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, intesi sia come
entità divine che demoniache), né effigi religiose, né
santuari, né luoghi sacri costruiti dall'uomo (13).
(1) O. Sturfrintz,
The Indo-European Heritage, Allister, Bristol 2004, pp. 81
ss.
(2) AA.VV., Oxford Dictionary of English
Etymology, Oxford, O.U.P. 1966, p. 92.
(3) AA.VV., Encylopedia Britannica, vol. 8,
pp. 143 ss.
(4) P. Ausmann, The Genetical issue of
Haplogroup I1a, History Review, IX-7, Baltimora 2004.
(5) E. Lamberth, The making of Germanic Culture,
Ashworth, Londra, 2006, pp. 99 ss.
(6) H. Kinder,W. Hilgemann, The Penguin Atlas of
World History, Penguin Books, Londra 2001, passim.
(7) J.B.Bury, The Invasion of Europe by
Barbarians, Lewis Books, Londra e New York 2000, pp. 21-27.
(8) O. Hermann, The Germanic Culture,
Avalon, New York 1993, pp. 73-74.
(9) S.Fischer-Fabian, I Germani, Garzanti,
Milano 1985, passim.
(10) H. Wolfram, History of the Goths,
Berkeley, University of California Press 1988, passim
(11) S.Fischer-Fabian cit., passim.
(12) I.M.Ferris, Enemies of Rome: Barbarians
through Roman Eyes, Gloucestershire, Paths 2000, pp. 98 ss.
(13) H. Arelian, The Barbaric Conversion,
Hammer, Toronto 1999, pp. 237-261.
|
