 “Gotico”:
quante volte abbiamo sentito questo termine? “Gotica” fu
l'invasione che travolse l'Impero di Roma, o almeno quello che
ne restava; “gotica” fu l'arte che informò di sé, senza per
altro alcun reale contatto con l'originaria cultura gotica, il
medioevo; “gotica” è, persino, oggi, una sub-cultura giovanile
improntata, più che altro, ad un certo “ossianismo”. “Gotico”:
quante volte abbiamo sentito questo termine? “Gotica” fu
l'invasione che travolse l'Impero di Roma, o almeno quello che
ne restava; “gotica” fu l'arte che informò di sé, senza per
altro alcun reale contatto con l'originaria cultura gotica, il
medioevo; “gotica” è, persino, oggi, una sub-cultura giovanile
improntata, più che altro, ad un certo “ossianismo”.
Ma cosa sappiamo realmente dei Goti originali? In realtà,
sebbene non si presentino come un popolo totalmente misterioso,
di essi e, in particolare, delle loro origini più remote,
conosciamo molto meno di quanto vorremmo...
 “Nomina
nuda tenemus”. Per i Goti, questa celebre frase de “Il
Nome della Rosa” è vera solo in parte e, anzi, proprio il
nome che i Goti si attribuirono, è, secondo molti, la nostra
miglior (per quanto discutibile e ampiamente discussa) traccia
per comprendere il periodo più antico della loro presenza
europea. Etimologicamente, infatti, “Guton” deriva dalla stessa
radice di “Gutar”, che, in norreno, stava ad indicare gli
abitanti dell'area del Gotland. Probabilmente, entrambi i
termini potevano discendere dal proto-germanico “Gutaniz” il cui
significato è, sostanzialmente, “coloro che versano”, intendendo
“coloro che versano il seme” e, di conseguenza, come
riscontrabile per gli etonimi di decine di popoli a tutte le
latitudini, semplicemente “gli esseri umani”(1).
Effettivamente, alcuni elementi starebbero ad indicare una
origine autoctona del “gruppo gotico” (inteso come sotto-insieme
di un ben più vasto gruppo germanico di migrazione dall'oriente)
nel Gotland. In primo luogo, infatti, il numero di similarità
riscontrate dal linguista Elias Wessén tra
lingua gotica e “Vetero-Gutnish” (la base della variante
germanica usata Gotland) sembrerebbero avvalorare una
possibilità in tal senso. In secondo luogo, nessuna
testimonianza vetero-norrena distingue i Goti dai Gutar, ed
anzi, alcune fonti “Nomina
nuda tenemus”. Per i Goti, questa celebre frase de “Il
Nome della Rosa” è vera solo in parte e, anzi, proprio il
nome che i Goti si attribuirono, è, secondo molti, la nostra
miglior (per quanto discutibile e ampiamente discussa) traccia
per comprendere il periodo più antico della loro presenza
europea. Etimologicamente, infatti, “Guton” deriva dalla stessa
radice di “Gutar”, che, in norreno, stava ad indicare gli
abitanti dell'area del Gotland. Probabilmente, entrambi i
termini potevano discendere dal proto-germanico “Gutaniz” il cui
significato è, sostanzialmente, “coloro che versano”, intendendo
“coloro che versano il seme” e, di conseguenza, come
riscontrabile per gli etonimi di decine di popoli a tutte le
latitudini, semplicemente “gli esseri umani”(1).
Effettivamente, alcuni elementi starebbero ad indicare una
origine autoctona del “gruppo gotico” (inteso come sotto-insieme
di un ben più vasto gruppo germanico di migrazione dall'oriente)
nel Gotland. In primo luogo, infatti, il numero di similarità
riscontrate dal linguista Elias Wessén tra
lingua gotica e “Vetero-Gutnish” (la base della variante
germanica usata Gotland) sembrerebbero avvalorare una
possibilità in tal senso. In secondo luogo, nessuna
testimonianza vetero-norrena distingue i Goti dai Gutar, ed
anzi, alcune fonti
 norreno-orientali
arrivano addirittura a utilizzare il termine Gutar proprio per
definire i Goti (così, ad esempio nella iscrizione runica di
Rökstone)(2). norreno-orientali
arrivano addirittura a utilizzare il termine Gutar proprio per
definire i Goti (così, ad esempio nella iscrizione runica di
Rökstone)(2).
Tutti questi elementi sono stati, comunque, come detto,
ampiamente discussi: fin dal XIX secolo, infatti, vi è stato chi
ha affermato che la presunta somiglianza tra Gotico e Gutnish
sia, in effetti, apparente, non presentando le due lingue che le
normali comunanze di tutti i dialetti germanici (3)
e che, in realtà, vi siano molte più probabilità (il che è,
comunque, molto discutibile) che il nome di questo popolo derivi
dal Göta älv, un fiume del Västergötland in Svezia, che
congiunge il lago Vänern al Kattegat (4).
Soprattutto, in una serie di studi tra il 1982 e il 1992,
Witold Mańczak, sulla base di interessanti
studi linguistici, ha tentato di dimostrare come, per la
vicinanza molto maggiore tra gotico e idiomi germanici che tra
gotico e lingue scandinave, sia possibile ritenere che il luogo
d'origine dei Goti sia piuttosto la Germania meridionale che il
Gotland (5).
In questo caso, potremmo semplicemente
pensare al Gotland come una tappa migratoria intermedia,
probabilmente con uno stanziamento prolungato, ma non come alla
terra che diede i natali alle formazioni di un
sub-raggruppamento gotico.
 Ciò
che, però, rende una tale teoria, per altro
perfettamente logica, almeno problematica, è che
non troverebbe alcuna rispondenza nella sola
testimonianza storiografica attendibile sui Goti
scritta nell'antichità, quella “De Origine
Actibusque Getarum” (6)
del monaco Iordane (551 d.C.), pubblicata dal
Momsen nei “Monumenta
Germaniae Historica” e
divenuta il caposaldo per la ricostruzione delle
migrazioni gotiche precedenti al contatto con
Roma. Ciò
che, però, rende una tale teoria, per altro
perfettamente logica, almeno problematica, è che
non troverebbe alcuna rispondenza nella sola
testimonianza storiografica attendibile sui Goti
scritta nell'antichità, quella “De Origine
Actibusque Getarum” (6)
del monaco Iordane (551 d.C.), pubblicata dal
Momsen nei “Monumenta
Germaniae Historica” e
divenuta il caposaldo per la ricostruzione delle
migrazioni gotiche precedenti al contatto con
Roma.
Iordane, al capitolo II della sua opera,
infatti, certifica chiaramente una origine prima
nell'area scandinava (7)
e, per lungo tempo, ciò ha significato mettere
un punto fermo alle ricerche sulla questione.
Lo storico bizantino,
infatti, pur non essendo il primo autore a
trattare dei Goti (le “Res Gestae”
di Ammiano Marcellino sono di almeno un secolo
precedenti, così come precedente, seppure di
poco, è il “De Bello Gotico”
di Procopio), deriva la sua “autoritas”, come
sottolineato una ventina di anni fa da Peter
Heather, da almeno due elementi: il primo luogo,
il fatto di coprire estesamente l'intero arco
della storia gotica (mentre gli altri autori ne
trattano unicamente in relazione allo scontro
con Roma e con solo vaghi accenni ai periodi
precedenti); in secondo luogo, dall'origine
stessa di Iordane, che si dice di razza gotica e
che attinge pesantemente sia ad opere
precedenti, per noi perdute, di Ablabio e di
Cassiodoro (quasi certamente scritte su ordine
di re germanici, quindi attingendo a
testimonianze dirette), che a resoconti orali da
lui ascoltati in gioventù (8).
In
realtà, però, proprio questo punto ci permette
di dubitare sull'oggettività del monaco-storico:
egli stesso riporta altre ipotesi e varianti
sulla origine del suo popolo e l'origine
scandinava da lui prescelta come più rispondente
alla realtà effettuale, è, in realtà, solo una
delle possibili scelte soggettive, compiute
forse da lui stesso, forse dalle sue fonti,
all'interno di una idea generica di origine
“nordica” (ricordiamo che il concetto di “Thule”
era a dir poco nebuloso e piuttosto indistinto
in periodo proto-alto-medievale), circolante nel
periodo di composizione del “De
Origine”,
probabilmente, come messo a fuoco dal Wolfram,
anche in
 relazione
alle tradizioni di clan gotici dominanti a
Bisanzio (9).
Storicamente, però, alcuni elementi non sembrano
rientrare così facilmente nel quadro messo a
punto da Iordane: numerosi indizi storici (usi,
termini, linguaggio) sembrerebbero indicare,
come rilevato da Hachmann (10),
che i Goti avessero attraversato il Baltico da
sud a nord e non viceversa; Heather afferma che
non vi sia alcuna prova di una migrazione dal
Baltico verso il Mar Nero e anzi, che sarebbe
assurdo pensare ad una migrazione da aree più
fertili ad aree meno fertili, attraversando, per
di più, i territori degli Slavi Carpatici (11);
infine, è altamente improbabile che i Germani
che diedero poi origine ai Goti si comportassero
diversamente dalle altre tribù germaniche, la
cui tendenza era quella di muoversi verso aree
di civiltà più ricche in un andamento che,
costantemente, prima delle grandi pressioni
delle popolazioni da oriente, è stato
direzionato verso sud-ovest e non verso nord (12).
Su queste basi, sembrerebbe più plausibile che
l'area di origine dei Goti sia, più o meno,
l'odierna Austria e che, anzi, il nucleo
“gotico” originario sia stato piuttosto esiguo e
che si sia andato via vai ingrandendo per un
processo di assimilazione progressiva di altre
tribù minori. relazione
alle tradizioni di clan gotici dominanti a
Bisanzio (9).
Storicamente, però, alcuni elementi non sembrano
rientrare così facilmente nel quadro messo a
punto da Iordane: numerosi indizi storici (usi,
termini, linguaggio) sembrerebbero indicare,
come rilevato da Hachmann (10),
che i Goti avessero attraversato il Baltico da
sud a nord e non viceversa; Heather afferma che
non vi sia alcuna prova di una migrazione dal
Baltico verso il Mar Nero e anzi, che sarebbe
assurdo pensare ad una migrazione da aree più
fertili ad aree meno fertili, attraversando, per
di più, i territori degli Slavi Carpatici (11);
infine, è altamente improbabile che i Germani
che diedero poi origine ai Goti si comportassero
diversamente dalle altre tribù germaniche, la
cui tendenza era quella di muoversi verso aree
di civiltà più ricche in un andamento che,
costantemente, prima delle grandi pressioni
delle popolazioni da oriente, è stato
direzionato verso sud-ovest e non verso nord (12).
Su queste basi, sembrerebbe più plausibile che
l'area di origine dei Goti sia, più o meno,
l'odierna Austria e che, anzi, il nucleo
“gotico” originario sia stato piuttosto esiguo e
che si sia andato via vai ingrandendo per un
processo di assimilazione progressiva di altre
tribù minori.
Fu, probabilmente, a partire da questa
assimilazione che, come riportato dalla maggior
parte delle leggende gotiche, si creò un
problema demografico in territori piuttosto poco
produttivi. A ciò va, senza dubbio, unita la
pressione romana da sud e il risultato fu uno
spostamento verso nord-est che definì un'area di
stanziamento prolungato tra Oder e Vistola,
nell'odierna Polonia, con propaggini verso nord
(appunto fino al Gotland) e un progressivo
scivolamento verso la Scitia (l'odierna
Ucraina). Queste regioni, a loro volta,
contenevano già una notevole mescolanza di
etnie, a cui i Goti, proseguendo nella loro
tendenza assimilatoria, con ogni evidenza si
unirono, creando una popolazione tutt'altro che
omogenea, ma certamente numericamente di grande
importanza.
Verso la metà del III secolo, tale forza
numerica si manifestò nel contato con i
Romani, quando un esercito gotico attraversò
il Danubio (238 d.C.) e, prima di ritirarsi,
compì devastazioni tali da potersi
permettere di estorcere grandi quantità di
denaro ai possidenti locali solo per
andarsene.
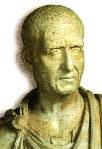  Non
ci volle molto prima che contingenti sempre
maggiori di Goti entrassero nei ranghi
dell'esercito imperiale come “guardie del
limes” ed è persino probabile che venisse
stipulato addirittura un trattato formale in
tal senso con l'imperatore Gordiano III.
Ciò, comunque, non prevenne (e forse favorì)
una seconda invasione nel 250, quando i
Goti, guidati dal loro re Kniva, al comando
anche di altre tribù germaniche, fra cui i
Vandali, e di numerosi disertori romani,
penetrarono profondamente a sud e
sbaragliarono le truppe dell'imperatore
Decio a Filippopoli e, dopo aver
saccheggiato la città, di nuovo a Abritto
nel 251. Non
ci volle molto prima che contingenti sempre
maggiori di Goti entrassero nei ranghi
dell'esercito imperiale come “guardie del
limes” ed è persino probabile che venisse
stipulato addirittura un trattato formale in
tal senso con l'imperatore Gordiano III.
Ciò, comunque, non prevenne (e forse favorì)
una seconda invasione nel 250, quando i
Goti, guidati dal loro re Kniva, al comando
anche di altre tribù germaniche, fra cui i
Vandali, e di numerosi disertori romani,
penetrarono profondamente a sud e
sbaragliarono le truppe dell'imperatore
Decio a Filippopoli e, dopo aver
saccheggiato la città, di nuovo a Abritto
nel 251.
 Nuove
invasioni seguirono, così come attacchi via
mare, che portarono addirittura alla
conquista di Trebisonda. A questo punto,
cominciò una vera e propria invasione di
massa dell'Asia Minore, con enormi saccheggi
e bottini che inclusero quantità
elevatissime di schiavi. Paradossalmente, fu
questo e non il momento della conquista di
Roma il vero apice del dominio dei Goti (13). Nuove
invasioni seguirono, così come attacchi via
mare, che portarono addirittura alla
conquista di Trebisonda. A questo punto,
cominciò una vera e propria invasione di
massa dell'Asia Minore, con enormi saccheggi
e bottini che inclusero quantità
elevatissime di schiavi. Paradossalmente, fu
questo e non il momento della conquista di
Roma il vero apice del dominio dei Goti (13).
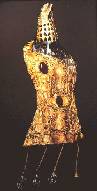 Ma
è possibile parlare realmente di una
popolazione gotica? In realtà, almeno
fino al loro stanziamento sul Mar Nero,
una vera e propria cultura gotica non si
sviluppò mai. Come abbiamo visto,
sarebbe il caso di parlare, più che
altro, di una grande federazione
germanica di tribù, capace, grazie ad un
fortissimo spirito di assimilazione, di
coalizzare gruppi diversi, uniti da
necessità migratorie o di saccheggio e
progressivamente sempre più formalmente
inquadrati in strutture di tipo
semi-monarchico. Ma
è possibile parlare realmente di una
popolazione gotica? In realtà, almeno
fino al loro stanziamento sul Mar Nero,
una vera e propria cultura gotica non si
sviluppò mai. Come abbiamo visto,
sarebbe il caso di parlare, più che
altro, di una grande federazione
germanica di tribù, capace, grazie ad un
fortissimo spirito di assimilazione, di
coalizzare gruppi diversi, uniti da
necessità migratorie o di saccheggio e
progressivamente sempre più formalmente
inquadrati in strutture di tipo
semi-monarchico.
Non è un caso che i vari ritrovamenti
Goti precedenti alla metà del III secolo
(della necropoli slovena di Dravlje,
posta a nord di Lubiana, l'antica Emona,
ai recentissimi rinvenimenti carinziani
di Globasnitz, ai piedi dell'Hemmaberg),
rechino tracce di costumi molto diversi
tra loro, quasi che i Goti si
presentassero, per certi versi, come una
epitome di tutti i popoli germanici
orientali (14).
 Solo
raggiunte le coste del Mar Nero
settentrionale, i Goti si mescolarono ai
gruppi nomadi locali di cultura scitica
e sarmatica (in particolare Alana) e
alle popolazioni autoctone della costa
del Mar Nero, di matrice culturale
greco-romana, costituendo una parvenza
di stato tribale, retto da potenti
gruppi aristocratici dediti al commercio
di pelli, pellicce, legname e Solo
raggiunte le coste del Mar Nero
settentrionale, i Goti si mescolarono ai
gruppi nomadi locali di cultura scitica
e sarmatica (in particolare Alana) e
alle popolazioni autoctone della costa
del Mar Nero, di matrice culturale
greco-romana, costituendo una parvenza
di stato tribale, retto da potenti
gruppi aristocratici dediti al commercio
di pelli, pellicce, legname e pesce. Diedero così luogo, finalmente,
ad una cultura gotica, in continuità
comunque con le precedenti culture della
regione, e, mescolandosi con la
popolazione locale, pur creando
aristocrazie separate, sempre in una
tendenza sincretistica che parrebbe
essere l'elemento più
connotante dell'insieme di popoli
federati, assorbirono numerosissimi
elementi completamente estranei ad una
radice germanica pura. Non è un caso che
i manufatti in metallo prezioso di epoca
gotica si collochino lungo la linea
artistica di sviluppo ed evoluzione già
suggerita dalla compagine tribale
sarmatica, in cui l’oro si mescola e si
arricchisce costantemente grazie ad
inserti in pietre semipreziose policrome
e che uno degli elementi più
interessanti ritrovati nelle sepolture
gotiche sia la presenza di evidenti
tracce di pratiche per la deformazione
dei crani, eseguite per motivi estetici
e tipiche, anche come riconoscimento di
rango, di numerose popolazioni di
origine orientale (15).
pesce. Diedero così luogo, finalmente,
ad una cultura gotica, in continuità
comunque con le precedenti culture della
regione, e, mescolandosi con la
popolazione locale, pur creando
aristocrazie separate, sempre in una
tendenza sincretistica che parrebbe
essere l'elemento più
connotante dell'insieme di popoli
federati, assorbirono numerosissimi
elementi completamente estranei ad una
radice germanica pura. Non è un caso che
i manufatti in metallo prezioso di epoca
gotica si collochino lungo la linea
artistica di sviluppo ed evoluzione già
suggerita dalla compagine tribale
sarmatica, in cui l’oro si mescola e si
arricchisce costantemente grazie ad
inserti in pietre semipreziose policrome
e che uno degli elementi più
interessanti ritrovati nelle sepolture
gotiche sia la presenza di evidenti
tracce di pratiche per la deformazione
dei crani, eseguite per motivi estetici
e tipiche, anche come riconoscimento di
rango, di numerose popolazioni di
origine orientale (15).
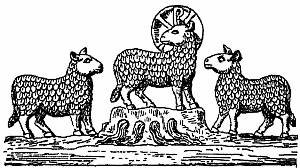 Quasi
paradossalmente, fu, comunque, un
elemento completamente esterno sia alla
cultura germanica che a quella sarmatica
a divenire l'elemento più unificante e
caratterizzante della popolazione
gotica: l'arianesimo cristiano. Quasi
paradossalmente, fu, comunque, un
elemento completamente esterno sia alla
cultura germanica che a quella sarmatica
a divenire l'elemento più unificante e
caratterizzante della popolazione
gotica: l'arianesimo cristiano.
E' probabile che già gli schiavi
razziati nel territorio di Bisanzio
avessero iniziato ad introdurre il
cristianesimo tra i Goti (che, fino a
quel momento, erano temuti per la loro
devozione agli dei della mitologia
germanico-orientale, tanto che tutti i
prigionieri di guerra venivano
sacrificati al dio della guerra, Tyz, il
dio con una sola mano, e le loro braccia
venivano appese ad alberi come offerte).
La grande opera di evangelizzazione, si
deve comunque a un monaco goto, nato
probabilmente attorno al 311 e cresciuto
a Bisanzio: Ulfila.
 Ulfila
era stato consacrato vescovo addirittura
da uno dei maggiori leader della
corrente ariana, Eusebio di
Costantinopoli e, all'inizio del IV
secolo, anche grazie alla sua traduzione
del Vangelo in lingua gotica, la sua
predicazione ottenne un enorme successo
tra la nobiltà stanziata sul Mar Nero e,
conseguentemente, tra tutti i guerrieri
legati ai nobili attraverso vincoli di "sippe"
(sebbene, molto spesso, il Cristo degli
Ariani venisse scambiato come un eroe
leggendario, sul modello delle divinità
del Walhalla), tanto che i Goti
divennero essi stessi i maggiori
evangelizzatori di tutto il mondo
germanico. Per uno strano scherzo del
destino, circa un secolo e mezzo dopo,
l'arianesimo gotico diventerà uno dei
maggiori elementi di distinzione etnica
tra germani e romani cattolici (16). Ulfila
era stato consacrato vescovo addirittura
da uno dei maggiori leader della
corrente ariana, Eusebio di
Costantinopoli e, all'inizio del IV
secolo, anche grazie alla sua traduzione
del Vangelo in lingua gotica, la sua
predicazione ottenne un enorme successo
tra la nobiltà stanziata sul Mar Nero e,
conseguentemente, tra tutti i guerrieri
legati ai nobili attraverso vincoli di "sippe"
(sebbene, molto spesso, il Cristo degli
Ariani venisse scambiato come un eroe
leggendario, sul modello delle divinità
del Walhalla), tanto che i Goti
divennero essi stessi i maggiori
evangelizzatori di tutto il mondo
germanico. Per uno strano scherzo del
destino, circa un secolo e mezzo dopo,
l'arianesimo gotico diventerà uno dei
maggiori elementi di distinzione etnica
tra germani e romani cattolici (16).
(1) D. H. Green,
Language and History in
the Early Germanic World , C.U.P., Cambridge
1998, pp. 88 ss.
(2) Ivi, pp.
97-99.
(3) G. Hollowitz,
Historia Germaniae,
Hauffman, Berlin 1891, pp. 654 ss.
(4) H. Wolfram, History of the Goths,
Berkeley, University of California Press 1988, p. 282.
(5) W.Mańczak,
Kamen die Goten aus
Skandinavien?, in: IF 87, 1982, pp. 127-137.
(6) Jordanes, The
Origins and Deeds of the Goths, Dodo, Sydney
2007.
(7)
Ivi, I.2.
(8) P. Heather,
Goths and Romans 332-489, O.U.P., Oxford 1991,
pp. 121-126.
(9) H.Wolfram, Cit.,
p. 291-293.
(10) R.Hachmann,
Die Goten und Skandinavien, IGP, Berlin 1970, pp.
411 ss.
(11) P. Heather,
cit., pp. 136
ss.
(12) A. Aardberg,
The German Tribes: a nomadic conquest, Galmayer,
Denver 1999, pp. 176-180.
(13) Ivi,
pp.186.
(14) L. Lynne, The
Goths, P.U.P., 2004, p. 79.
(15) E. Oosgwoord,
The Germans on the Black Sea, Accademic Press,
Baltimora 1993, pp. 165 ss.
(16) H. Chadwick, The
Early Church, Penguin Classic, London 1986, pp.
176 ss.
|
