|
Le
repubbliche marinare
L’incremento
degli scambi commerciali avvenuto dopo il Mille in tutto l’Occidente
non si sarebbe mai verificato senza il commercio marittimo. Cuore del
commercio europeo, il Mediterraneo, disseminato di isole che
facilitavano la navigazione, trovava nella penisola italiana il suo
fulcro. Dominato fin dal VII secolo dalla marineria araba, che aveva
costretto sulla difensiva anche le flotte bizantine, cominciava a
vedere sulle sue coste il sorgere di nuove potenze marittime: le repubbliche
marinare. In realtà le città costiere avevano mantenuto un
livello minimo di relazioni commerciali con l’Impero bizantino e con
l’Islam anche nei secoli precedenti. Sull’Adriatico Venezia era il
crocevia fin dall’età carolingia dei traffici con il Levante:
grazie a un privilegio del 1082, ottenne dallo stesso imperatore
bizantino Alessio Comneno il diritto di commerciare nei territori dell’Impero
in regime di esenzione fiscale. Nel Tirreno meridionale erano attive
Napoli, Gaeta, Salerno ma soprattutto Amalfi che, fino alla conquista
normanna (1073), costituì un centro di scambi, in particolare con l’Egitto.
La sua decadenza coincise con l’affermazione definitiva di Genova e
Pisa.
Queste
due città raggiunsero in breve un’espansione commerciale e un’autocoscienza
politica che le rese in grado, a partire dall’XI secolo, di lanciare
con successo una campagna di riconquista delle basi mediterranee in
mano ai musulmani. Nel 1015-1016, con un’azione congiunta,
intervennero in Sardegna scongiurando la creazione di uno Stato
islamico nell’isola; nel 1087 conquistarono il porto tunisino di
Mahdiyah, considerato uno dei principali centri del commercio del
Mediterraneo; nel 1092, attaccarono Tortosa. Nel 1034 i Pisani
saccheggiarono la città africana di Bona e, nel 1064, il porto di
Palermo. La prima crociata (1096-99) offrì ai mercanti delle due
città tirreniche la possibilità di acquisire nuove basi economiche e
territoriali per i loro traffici. Tra il 1113 e il 1116 Pisa
organizzò una grande spedizione contro le Baleari costringendole a
stipulare un oneroso trattato commerciale. La fama dei Genovesi e dei
Pisani non era comunque legata unicamente alle azioni di pirateria
compiute ai danni delle navi dell’Islam. Ma azioni di questo genere
erano comuni anche contro le navi delle altre città marinare e
concorrenti. Per far fronte a questo onnipresente pericolo, i convogli
marittimi imbarcavano militari specializzati per la difesa dell’imbarcazione.
A Venezia si arrivò a stabilire che su dieci membri dell’equipaggio
dovessero esserci almeno due balestrieri.
L’espansione
commerciale nel Mediterraneo fu resa possibile anche dal fatto che le
imbarcazioni divennero sempre più affidabili e di grandi dimensioni.
Fondamentalmente erano di due tipi: la galea, lunga e sottile, che
impiegava la spinta dei rematori, e la nave vera e propria (navis
in latino, nef in francese, nau in catalano),
tondeggiante e panciuta, meno veloce perchè sfruttava esclusivamente
la forza del vento, ma più capiente. Più veloce e con una
possibilità di carico minore, la galea era particolarmente adatta per
la guerra, ma veniva usata anche per fini commerciali. I banchi dove
sedevano i rematori erano disposti su un unico ordine, a file di un
banco per ogni lato. Fino alla fine del XIII secolo i rematori erano
due per banco, ma successivamente essi divennero tre, modifica che fu
resa possibile grazie all’ampliamento dello scafo. In questo modo
progredì anche la capacità di carico fino a raggiungere, alla fine
del Medioevo, le 200 tonnellate. Tra il XII e XIII secolo crebbero
anche le dimensioni delle imbarcazioni a vela.
Uno
dei progressi più significativi fu il passaggio dall’uso di vele di
forma triangolare (dette latine) ad una velatura mista. L’albero
maestro era infatti riservato a una grossa vela quadra, mentre l’albero
posteriore e quello anteriore (quando presente) continuavano a
impiegare vele triangolari più piccole. Grazie a raffigurazioni
risalenti agli anni Quaranta del XIII secolo, sappiamo che le navi
vennero munite di un timone incernierato al centro della poppa che
andava a sostituire i due grossi legni laterali pendenti all’indietro.
Nelle varie descrizioni dei viaggiatori occasionali - pellegrini in
Terrasanta, crociati o mercanti alle prime armi - la navigazione era
rischiosa e disagevole. A bordo delle navi, scarsissimo era lo spazio
individuale e continua l’esposizione alle intemperie. Frequenti
erano le malattie dovute alla cattiva alimentazione e alla mancanza d’igiene.
Elevata era anche la probabilità di incontrare navi pirati o quella
di fare naufragio: il disastro poteva essere provocato
da una tempesta, un basso fondale, un urto contro gli scogli,
il passaggio in uno stretto difficile.
L’iniziativa della costruzione di una nave, la sua proprietà e la sua
navigazione erano funzioni distinte, regolate da contratti. Dalla
documentazione sappiamo che la proprietà, quando non era pubblica,
era generalmente divisa in quote (“parti” o “carati”) e
ripartita fra diversi proprietari. La responsabilità sia della
conduzione commerciale sia di quella nautica ricadeva, invece, su un
unico armatore, il patronus, spesso anche comproprietario della
nave. I marinai, compresi i rematori delle galee, erano dei salariati
liberi (solo nei secoli successivi fecero la loro comparsa i carcerati
e gli schiavi), che intraprendevano la navigazione seguendo tradizioni
locali e familiari, ma anche perchè i salari erano superiori a quelli
che avrebbero potuto percepire a terra. In virtù del “diritto di
paccottiglia”, ogni marinaio poteva portare con sé una piccola
quantità di merci da vendere o scambiare. Diritti e doveri dei
marinai erano normalmente fissati dalla legislazione delle città
marittime. Non si deve però credere che l’autorità che il patrono
poteva esercitare su di loro fosse assoluta. Come risulta da testi
quali la Tavola di Amalfi e il catalano Consolat de mar,
molte decisioni dovevano essere prese a maggioranza con la
partecipazione di tutti gli imbarcati.
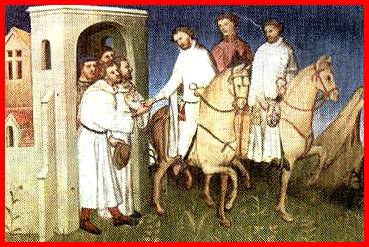
Marco,
Matteo e Niccolò Polo
Per
entrare in contatto direttamente con i mercati asiatici – per i beni
di lusso più richiesti in Occidente come i tessuti di seta e le
spezie - e eliminare la mediazione commerciale degli Arabi e dei
Turchi, i Veneziani e i Genovesi intrapresero viaggi avventurosi. Nel
XIII secolo, grazie alle maggiori garanzie di sicurezza offerte dalla
formazione del grande Impero mongolo, queste iniziative divennero più
numerose. Il nome più famoso è senz’altro quello di Marco Polo,
sia per la durata e la vastità dei viaggi intrapresi, sia per il
racconto che di essi ci è pervenuto attraverso Il Milione. Ma
il veneziano non fu affatto l’unico. Altri mercanti europei sono
segnalati in Cina, in India, lungo il Volga, nel Turkestan, in Persia.
Tentativi di espansione commerciale si registrarono anche verso Ovest,
soprattutto per iniziativa di navigatori genovesi che, superato lo
stretto di Gibilterra, esplorarono le coste atlantiche dell’Africa
raggiungendo le miniere d’oro del Senegal. Nel 1291 i fratelli
Vivaldi intrapresero un lungo viaggio precedendo, forse, quello che
due secoli più tardi fece Cristoforo Colombo, con l’obiettivo di
raggiungere le Indie viaggiando verso Occidente, ma scomparvero poco
dopo avere raggiunto le Canarie. I confini del commercio marittimo,
comunque, si allargarono oltre il Mediterraneo solo nel XIV secolo,
quando la costruzione di imbarcazioni più veloci e capienti spinse
Genovesi e Veneziani ad allacciare rapporti commerciali con i porti
principali della Francia, dell’Inghilterra e delle Fiandre.
Guelfi
e Ghibellini
La vita delle città italiane nei secoli XIII-XIV fu contrassegnata da
aspre lotte intestine, iniziate fin dalla prima metà del 1100, tra le
grandi famiglie nobiliari. I Comuni difficilmente furono in grado di
elaborare una politica di ampio respiro capace di realizzare una
coesione tra i diversi ceti sociali cittadini. All'interno delle mura
le fazioni si resero protagoniste di continue violenze con
l’obiettivo di eliminare o cacciare dalla città la parte avversa.
È in questo periodo che nasce la suddivisione in Guelfi e
Ghibellini.
Dopo
la morte di Federico Barbarossa, avvenuta nel 1190, i successivi
tentativi di limitare le autonomie cittadine effettuati dagli
imperatori tedeschi furono occasionali e inconcludenti. Lo situazione
mutò radicalmente con la comparsa sulla scena del nuovo imperatore,
Federico II di Svevia, uno dei personaggi più affascinanti e
enigmatici del Medioevo. Nato dal matrimonio fra Enrico VI, figlio del
Barbarossa, e Costanza d’Altavilla, ultima erede della monarchia
normanna di Sicilia, Federico II assunse la corona del Regno di
Sicilia, quella di Germania e, dal 1220, quella imperiale. Ebbe come
tutore papa Innocenzo III; Onorio III gli conferì la dignità
imperiale. Eletto imperatore, Federico II riprese il progetto del
Barbarossa, puntando a riaffermare la piena autorità imperiale sul
regno d’Italia e il controllo sui territori della Chiesa. Questa fu
la scintilla che scatenò un duro scontro con Gregorio IX e Onorio IV.
Per avere una maggiore libertà di manovra, fece eleggere sul trono di
Germania, in qualità di coreggente, il figlio Enrico e concesse ai
principi tedeschi ampi poteri, per ottenere il loro appoggio per
ricondurre all’obbedienza le città dell’Italia
centro-settentrionale, trasformando la penisola in un enorme campo di
battaglia. In base al gioco degli interessi locali, nelle varie città
nacquero un partito filo-papale (o “guelfo”) e uno filo-imperiale
(o “ghibellino”). I primi si rifacevano ai conti di Baviera e di
Sassonia, cioè ai discendenti di quel Guelfo IV che, verso la metà
del XII secolo, si era invano opposto all’incoronazione di Corrado
III. I secondi sostenevano invece la casata sveva degli Hohenstaufen,
signori del castello di Weiblingen.
Guelfi e ghibellini furono, dunque, etichette. Entrambe le fazioni
traevano il proprio nome e legittimazione politica dai due
tradizionali schieramenti che, nell’Europa occidentale,
contrapponevano i fautori del papa e i sostenitori dell’imperatore.
I gruppi contrapposti si professavano di parte guelfa o ghibellina con
il solo scopo di ottenere appoggi o favori da parte del Pontefice, o
degli Angioini (Carlo d’Angiò venne chiamato direttamente in Italia
da Urbano IV nel 1262 per mettere fine al potere dello svevo Manfredi
sull’Italia meridionale), oppure dall’imperatore, dagli Svevi o
dagli Aragonesi.
La contrapposizione ideologica e le lotte intestine nelle città
italiane furono profonde e viscerali, connotando ogni atto, ogni
minimo episodio della vita cittadina. La divisione fu particolarmente
forte e significativa in Toscana che portò a coalizioni di città
contro città. Numerose furono anche le occasioni di guerra e
battaglie campali. Ricordiamo Montaperti, Colle Valdelsa, Tagliacozzo
e Campaldino, tanto per citare alcuni degli esempi più famosi.
Quando, nel 1237, l’esercito di Federico II sconfisse a Cortenuova
le truppe della Lega lombarda, la vittoria sembrava alla portata della
fazione imperiale, ma alcuni errori politici e l’ostilità del papa
(che arrivò alla scomunica di Federico nel 1239, per poi dichiararlo
deposto nel 1245, sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà),
ne decretarono la sconfitta. Federico II non fece in tempo a preparare
la sua riscossa: la morte lo colse, infatti, nel 1250, all’età di
cinquantasei anni. Dopo di lui il partito ghibellino conobbe una lenta
ma progressiva sconfitta in tutta la penisola.
I
mutamenti nell’attività mercantile e le corporazioni
Il mondo della
produzione urbana, almeno nella sua prima fase, era indissolubilmente
legato all’artigiano e alla sua bottega. Tale era il fabbro, il
calzolaio, il sarto, il tessitore, l’orafo, il fornaio. Nella
bottega artigiana, oltre all’artigiano, poteva lavorare qualche
membro della famiglia e, non raramente, un aiutante esterno.
L’addestramento del personale avveniva principalmente attraverso
l’apprendistato, un lungo periodo di formazione alla fine del quale
il discepolo era pronto per diventare a sua volta “maestro”.
Spesso l’apprendista, o garzone, era poco di un bambino. In genere
il contratto stipulato fra l’artigiano e il padre
dell’apprendista, prevedeva che il ragazzo si trasferisse alle
dipendenze della bottega per un certo numero di anni, variabile in
base al mestiere.
Con lo sviluppo dei
commerci la situazione cambia e si assiste a un’evoluzione
dell’industria su grande scala finalizzata all’esportazione,
specialmente nella fabbricazione di stoffe e panni di qualità
medio-alta. Nei secoli XIII-XIV vi erano in Europa regioni nelle quali
esistevano vere e proprie aree specializzate: tali erano l’area
fiammingo-brabantese, l’Italia centro-settentrionale e
l’Inghilterra. A Bruges, nel 1340, i tessili costituivano quasi il
40% di tutti gli occupati, e questa percentuale saliva ad oltre il 50%
nella vicina Ypres all’inizio del XV secolo; a Firenze, verso la
fine del Trecento, la sola manifattura laniera assorbiva il 35-40%
dell’intera popolazione attiva.
Nelle città dalla spiccata fisionomia industriale si sviluppò un
modello di organizzazione del lavoro distinto dall’artigianato
tradizionale: la cosiddetta industria disseminata. Le varie
operazioni del ciclo tessile (variamente organizzate secondo la natura
delle fibre) non si svolgevano in un’unica sede, ma in tutta una
serie di botteghe, abitazioni e laboratori gestiti ognuno da un
artigiano. L’elemento di raccordo era il mercante-imprenditore che
gestiva l’intero processo di trasformazione (è evidente che in
questo sistema l’autonomia degli artigiani veniva fortemente
limitata).
A seguito di queste trasformazioni la figura del mercante cominciò a
mutare. Se nei secoli XI e XII (e nella prima metà del XIII) si
spostava continuamente per concludere i propri affari, a partire dalla
seconda metà del XIII secolo divenne sempre più sedentario, facendo
viaggiare i suoi agenti (“fattori”). Le ragioni di questo
cambiamento vanno ricercate nel fatto che l’attività commerciale
veniva svolta sempre meno da singoli e sempre più da associazioni di
due o più operatori economici. A seconda che fossero impegnate nei
traffici marittimi o in quelli terrestri, si distinguevano due tipi
fondamentali di società: la commenda e la compagnia. La
prima si fondava su un accordo, relativo ad un solo affare, tra una
serie di soci fornitori di capitale ed un socio che effettuava il
viaggio e le relative transazioni commerciali: alla buona riuscita
dell’impresa i guadagni erano distribuiti fra tutti i partecipanti
in proporzioni precedentemente stabilite, quindi la società si
scioglieva. La seconda, basata all’inizio su nuclei familiari e,
successivamente, aperta anche a estranei, era un’associazione
stabile, nella quale ogni socio partecipava agli utili e alle perdite
in base alla quota di capitali investiti. Dotate di una maggiore forza
di espansione, le compagnie svilupparono un esteso sistema di filiali
nelle principali città europee, tutte dipendenti dalla casa madre
(tra le società più importanti ricordiamo quelle dei senesi Tolomei
e Salimbeni e quelle dei fiorentini Bardi e Peruzzi).
Lo sviluppo di un commercio di tipo sedentario, e le sue forme
societarie più complesse, determinarono l’affinamento delle
tecniche commerciali. La contabilità, all’inizio ridotta e
essenziale, ben presto si articolò in una serie di scritture (i libri
contabili), divise tematicamente. Il libro principale, dove venivano
registrati i conti finali o parziali, era il Libro Mastro (nel
Duecento era anche chiamato Libro dell’Entrata e dell’Uscita
o Libro del Dare e dell’Avere). A questa contabilità si
aggiunsero anche altri documenti e tecniche contabili e commerciali,
come le lettere commerciali - rendiconti settimanali,
informazioni sui cambi di valute, saldi, informazioni sui prezzi –
le lettere di cambio, simili ai moderni assegni
circolari, e la partita doppia (nella partita doppia uno
stesso dato era inscritto due volte, la prima a credito e la seconda a
debito, specificando creditori e debitori; il vantaggio di questo
nuovo sistema contabile, rispetto alla precedente registrazione, la
“partita semplice”, è che permetteva una verifica contabile più
esatta e veloce).
Con la seconda metà del XII secolo, e, più ancora nel XIII secolo, i
mercanti e gli artigiani cominciarono a organizzarsi in strutture
associative, dette Corporazioni
(in Italia Arti, Metiers o Guilde in Francia e
nelle Fiandre, Guilds in Inghilterra, Gremios in
Spagna). Come i Comuni, le Corporazioni erano il risultato di patti
giurati, stipulati fra individui che esercitavano lo stesso mestiere,
nate per difendere e tutelare gli interessi di chi vi aderiva
all’interno. Possedevano beni propri e esercitavano la loro
giurisdizione sugli iscritti, i quali erano tenuti a sottoporvisi e ad
accettare le sentenze di appositi magistrati eletti in seno
all’associazione.
Le Corporazioni riunivano artigiani e venditori specializzati, come
conciatori, tessitori, orefici, lanaioli, armatori, macellai,
eccetera. Accettavano come membri esclusivamente gli artigiani, mentre
apprendisti e lavoranti ne restavano esclusi; fra gli stessi
“maestri”, ovviamente, erano quelli più facoltosi a monopolizzare
le cariche di effettiva responsabilità. Proteggevano i propri
affiliati dalla concorrenza di mercanti e artigiani provenienti da
altre città e scoraggiavano la concorrenza di altri cittadini non
appartenenti alla corporazione. Altro punto cardine della loro attività
era anche controllare, attraverso il disciplinamento dell’istituto
dell’apprendistato, la formazione dei nuovi artigiani e garantire
un’uniformità qualitativa dei beni prodotti. Non bisogna infine
dimenticare che le Corporazioni non erano istituzioni di carattere
solamente economico, ma promuovevano anche la solidarietà e
l’assistenza fra i propri membri, nonché la realizzazione di opere
di carità collettiva e di culto religioso.
Alla fine del XIII secolo chi desiderava esercitare una professione era
tenuto a iscriversi in una di queste associazioni. Con l’aumentare
del loro peso economico, le corporazioni nel corso del XIII secolo
cominciarono a ritagliarsi sempre un maggiore spazio politico,
entrando in contrasto con le famiglie nobiliari e magnatizie, fino ad
arrivare a occupare importanti cariche cittadine. Con l’emergere
delle figure dei mercanti, non più itineranti ma stabilmente e
attivamente residenti nella città, si modificò il rapporto
tradizionale tra il capitale e il lavoro. Queste nuove attività,
infatti, sempre più complesse, richiedevano una disponibilità
finanziaria di gran lunga maggiore rispetto a quella di un semplice
artigiano. Il sistema corporativo cominciò a modificarsi e alcune
associazioni prevalsero su altre categorie. Avvenne così una
gerarchizzazione tra le arti, che, grazie ad alcune alchimie
elettorali, regolava i meccanismi delle rappresentanze nelle massime
magistrature comunali (si pensi alla divisioni delle arti in maggiori,
medie e minori avvenuta nella vicina Firenze). I lavoratori
dipendenti, apprendisti e donne erano esclusi dai diritti associativi
e sempre più marcata iniziava ad essere la distanza tra chi impegnava
capitali e le attività basate prevalentemente sul lavoro manuale,
quindi tra giudici, notai, mercanti e cambiatori e cuoiai, tessili,
ortolani, vetrai, albergatori e così via. Questa differenziazione si
rispecchiava anche nel campo religioso: durante le processioni,
organizzate per celebrare importanti ricorrenze religiose o civili, le
associazioni erano solite sfilare secondo un ordine prestabilito e
ogni corporazione, rispettando l’ordine gerarchico, raggruppava i
suoi soci.
Man
mano che il “Popolo” andava affermandosi, le varie consorterie
produssero statuti propri per affrancarsi e contrastare i ceti
aristocratici (ricordiamo che quando si parla di popolo si intende gli
artigiani e i mercanti, non la cittadinanza in generale). Venne
modificata anche l’organizzazione militare del “Popolo” che,
nella sua fase iniziale, da “societas” che riuniva le milizie dei
quartieri per opporsi alla forza dei magnati, divenne un organismo più
raffinato, fino a arrivare a dotarsi di nuove funzioni costituzionali
all’interno del Comune, prime fra tutte la creazione del “Capitano
del Popolo”.
Gli ultimi decenni del Basso Medioevo italiano (soprattutto i Comuni
dell’Italia settentrionale e Romagna e le Marche) furono
caratterizzati dal fenomeno delle signorie cittadine. La signoria fu
la risposta al desiderio di pace interna delle cittadinanze, di
rafforzamento militare, di concentrazione dei poteri, di capacità
decisionale contro il perpetuo scontro tra le fazioni cittadine
all’interno delle grandi famiglie e tra quest’ultime e le
Corporazioni. Per ovviare a queste situazioni, in molti casi, si
preferì concentrare i poteri di governo, più o meno durevolmente,
nelle mani di un individuo. Spesso i Signori appartennero a famiglie
aristocratiche, questo perchè godevano di prestigio e avevano legami
familiari e competenze militari e di governo da far sperare di essere
all’altezza di soddisfare i compiti cui erano chiamati.
All’istituzione della signoria si giunse per vie diverse. Talora il
Podestà o un altro magistrato cittadino, in particolare il Capitano
del popolo, mutarono il loro ufficio a tempo in ufficio a vita. Altre
volte fu la fazione vincitrice a proclamare signore il suo principale
rappresentante. In altri casi si scelse un signore per avere una guida
al di sopra delle parti, ripetendo, a distanza di un secolo, ciò che
era avvenuto con l’istituzione del Podestà. In alcuni casi il
signore era un cittadino, in altri un forestiero. Comunque,
indipendentemente dalla sua origine, il potere signorile fu sempre
legittimato da un’acclamazione popolare o dalle assemblee comunali.
Tra le signorie più famose ricordiamo i guelfi Della Torre che
occuparono il potere a Milano nel 1240, appoggiati dalla parte
popolare, e mai quali subentrarono, nel 1277, i ghibellini Visconti.
Nello stesso periodo, Verona era in mano ai ghibellini Della Scala (o
Scaligeri), Padova ai guelfi Da Carrara, Mantova ai guelfi Gonzaga,
Ferrara ai guelfi marchesi d’Este. Nella Romagna e nelle Marche si
ebbe un proliferare di signorie, in guerra fra loro, che traevano
orgine dalla debolezza del potere pontificio a cui erano formalmente
sottomesse: i Malatesta a Rimini, i Montefeltro a Urbino, i da Varano
a Camerino. Dal fenomeno della signoria rimasero più lungamente
immuni le grandi città marittime di Pisa, Genova e Venezia e i Comuni
toscani, probabilmente a causa della più complessa struttura sociale
di questi centri, dove la crescente importanza internazionale del
capitale mobile e degli interessi bancari e mercantili favorirono
casomai il sorgere di oligarchie di potere piuttosto che dittatoriali.
È significativo, comunque, sottolineare che tentazioni di questo
genere vi siano state: la stessa repubblica di Firenze, nella prima
metà del Trecento, conobbe i brevi esperimenti signorili di Carlo di
Calabria e di Gualtieri di Brienne.
|

