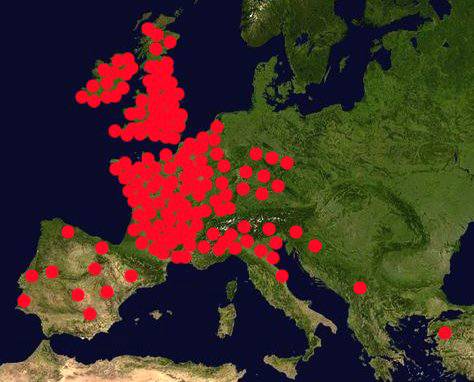I Celti sono probabilmente il popolo (o meglio
l'insieme di popoli di origine comune) più antico in cui ogni europeo
possa riconoscere la propria origine.
 Tra
il 900 ed il 400 a.C., il loro dominio si estendeva dal Ponto
alla Britannia e dal Mare del Nord alla penisola iberica. Eppure, su
questo grande insieme di genti accomunate da simili strutture sociali,
da una religione pressoché comune e da lingue dello stesso ceppo, il
silenzio dei libri di scuola è inspiegabilmente quasi totale. Tra
il 900 ed il 400 a.C., il loro dominio si estendeva dal Ponto
alla Britannia e dal Mare del Nord alla penisola iberica. Eppure, su
questo grande insieme di genti accomunate da simili strutture sociali,
da una religione pressoché comune e da lingue dello stesso ceppo, il
silenzio dei libri di scuola è inspiegabilmente quasi totale.
Sicuramente gioca molto l'immagine di
barbarie e primitivismo (in realtà per nulla confacente al vero) che
certa cultura illuminista ha attribuito a tutte le popolazioni
estranee alle civiltà ellenico-romane del Mediterraneo, una immagine
solo parzialmente riabilitata dal romanticismo (incluse le teorie,
spesso più fantasiose che scientifiche, della Irish
 Renaissance)
e che ha fatto sì che solo da pochissimi anni, anche sull'onda di
mode culturali quali quella della Next
Age, che, pur con una certa approssimazione, hanno voluto
vedere nella cultura celtica una sorta di antesignana dell'ecologismo
e dello spiritualismo naturalistico, si sia cominciato ad effettuare
seri studi antropo-storici sulle popolazioni celtiche. Renaissance)
e che ha fatto sì che solo da pochissimi anni, anche sull'onda di
mode culturali quali quella della Next
Age, che, pur con una certa approssimazione, hanno voluto
vedere nella cultura celtica una sorta di antesignana dell'ecologismo
e dello spiritualismo naturalistico, si sia cominciato ad effettuare
seri studi antropo-storici sulle popolazioni celtiche.
Di fatto, però, questo silenzio, questa "mistericità" che
ancora avvolge alcuni tratti della cultura più importante
sviluppatasi nell'Età del Ferro, è, in gran parte, un frutto proprio
di tale cultura, che non solo prediligeva, ma addirittura imponeva una
trasmissione unicamente orale del proprio sapere. Il risultato è che
ciò che conosciamo lo dobbiamo praticamente solo a fonti
scritte da "stranieri" venuti in contatto con i Celti, da
Cesare (1) a Strabone (2),
da Tito Livio (3) a Cassio Dione
(4), e non ai Celti stessi e
che, dunque, pur con i grandi passi avanti dovuti a numerose recenti
scoperte archeologiche, per ricostruire la maggior parte della storia
dei Celti, praticamente tutta quella che precede il VI secolo, ci
dobbiamo affidare unicamente a supposizioni.
Proviamo
a tracciare una linea evolutiva sulla base delle attuali conoscenze e
delle teorie più diffuse.
Abbiamo già detto che l'origine comune dei Celti è indoeuropea, ma non
abbiamo alcuna idea di quale fosse il nome che essi attribuivano alla
loro razza (sempre ammesso che si riconoscessero in un ceppo comune e
non unicamente nelle tribù o addirittura nei clan in cui erano divisi):
la parola "celtico" ha origine dal greco  keltai
usata dai Focei di Marsiglia per denominare questi
"barbari" con cui erano venuti a contatto. keltai
usata dai Focei di Marsiglia per denominare questi
"barbari" con cui erano venuti a contatto.
Sappiamo con certezza che la loro principale area di stanziamento
intorno all'inizio del I millenio a.C. doveva essere nell'Europa
centrale, tra la Boemia e la Baviera, ove i Celti entrarono in
contatto con la cosiddetta "Cultura di Unetice", legata
alla lavorazione dei minerali ed alla pastorizia (5).
Resta, però, ancora da capire come e quando fossero giunti in
quest'area e, in quest'ambito, le ipotesi sono numerose.  Secondo
alcune teorie (6), verso l'inizio
del IV millennio a.C.doveva esistere nella zona baltica una civiltà,
che potremmo definire proto-celtica e che alcuni, senza alcuna prova
effettiva, dipingono come "atlantidea", già
notevolmente progredita, con una cultura religiosa già fortemente
sviluppata in senso unitario e con una certa esperienza nella
navigazione. La capacità di spostamento di questi proto-celti e il loro
avanzamento scientifico sarebbero, secondo gli assertori di questa
ipotesi, provate dalle costruzioni megalitiche dei menhir della Bretagna
(Carnac), dell'Irlanda, del Galles e dell'Inghilterra (Stonehenge), che
dovevano avere come scopo la guida agli astri, in cui tali popolazioni
credevano. Secondo
alcune teorie (6), verso l'inizio
del IV millennio a.C.doveva esistere nella zona baltica una civiltà,
che potremmo definire proto-celtica e che alcuni, senza alcuna prova
effettiva, dipingono come "atlantidea", già
notevolmente progredita, con una cultura religiosa già fortemente
sviluppata in senso unitario e con una certa esperienza nella
navigazione. La capacità di spostamento di questi proto-celti e il loro
avanzamento scientifico sarebbero, secondo gli assertori di questa
ipotesi, provate dalle costruzioni megalitiche dei menhir della Bretagna
(Carnac), dell'Irlanda, del Galles e dell'Inghilterra (Stonehenge), che
dovevano avere come scopo la guida agli astri, in cui tali popolazioni
credevano.
A seguito di cataclismi e carestie, questo primo nucleo celtico
sarebbe migrato verso Europa centrale, Grecia
(dove avrebbero distrutto le culture achea e micenea), Anatolia, Palestina
ed Egitto, divenendo noto come Popoli
del Mare: solo l' Egitto riuscì a respingere la loro invasione,
la cui coda sarebbe stata rappresentata dai Dori che si stanziarono in
Grecia ed in Egeo. è, in effetti, probabile che i Dori fossero un
popolo di ceppo celtico, ma, alla luce di numerosi studi (7),
sia una identificazione dei Popoli del Mare con nuclei celtici, sia una
loro "discesa" da nord sono, in realtà, quantomeno dubbie.
 Secondo
un'altra teoria (8), ben più
accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:
i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del
Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine
indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una
migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero
entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si
sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale
(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).
La coda di questa migrazione
orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,
si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in
seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti
Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,
erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )
ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte
usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,
ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico
a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi
sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli. Secondo
un'altra teoria (8), ben più
accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:
i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del
Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine
indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una
migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero
entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si
sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale
(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).
La coda di questa migrazione
orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,
si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in
seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti
Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,
erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )
ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte
usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,
ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico
a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi
sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli.
 Due
teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno
conto della origine primaria della razza. Una terza
ipotesi (9), basata su studi etno-storici e
recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove
accennato (10), alcuni studiosi (11),
basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente
quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una
sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato
una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro
passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,
nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a
inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)
occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e
ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta). Due
teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno
conto della origine primaria della razza. Una terza
ipotesi (9), basata su studi etno-storici e
recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove
accennato (10), alcuni studiosi (11),
basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente
quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una
sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato
una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro
passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,
nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a
inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)
occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e
ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta).
 Quali che siano state le origini più remote
di questo ceppo etnico, fu in Europa centrale, intorno al 700 a.C.,
nella zona del Salzkammergut (Salisburgo e Carinzia), e fino al 450
a.C., che si sviluppò la prima vera cultura celtica, quella di Hallstatt,
resa fiorente dal commercio del sale e basata prevalentemente su due
classi sociali legate Quali che siano state le origini più remote
di questo ceppo etnico, fu in Europa centrale, intorno al 700 a.C.,
nella zona del Salzkammergut (Salisburgo e Carinzia), e fino al 450
a.C., che si sviluppò la prima vera cultura celtica, quella di Hallstatt,
resa fiorente dal commercio del sale e basata prevalentemente su due
classi sociali legate  all'aristocrazia
guerriera e al popolo dedito alla pastorizia. La fine della cultura
di Hallstatt, dovuta probabilmente a conflitti interni, con nuovi
ceti che aspirano al potere e soppiantano la vecchia aristocrazia hallstattiana (12),
segna l'inizio della cultura di La
Tene (450 - 50 a.C.), sviluppatasi sul lago di Neuchatel e
caratterizzata, oltre che da una spettacolare attività artistica,
soprattutto dalla nascita di una forte rete di commercio di massa e
dalla conseguente nascita di una protoborghesia (13).
Dalla zona tra basso Rodano e alto Danubio, a partire già
dal 700 circa a.C., principalmente per ragioni demografiche di sovrappopolamento, la loro espansione interessò le isole
britanniche (già raggiunte da una prima ondata precedente) e la
penisola iberica (Celtiberi)
e, successivamente, l'Italia settentrionale e i territori dei
Balcani, in cui vennero a contatto con l'impero di Alessandro Magno
e svolsero attività di mercenari, mentre una parte ritornò verso
l'Asia Minore (Galati) (14). all'aristocrazia
guerriera e al popolo dedito alla pastorizia. La fine della cultura
di Hallstatt, dovuta probabilmente a conflitti interni, con nuovi
ceti che aspirano al potere e soppiantano la vecchia aristocrazia hallstattiana (12),
segna l'inizio della cultura di La
Tene (450 - 50 a.C.), sviluppatasi sul lago di Neuchatel e
caratterizzata, oltre che da una spettacolare attività artistica,
soprattutto dalla nascita di una forte rete di commercio di massa e
dalla conseguente nascita di una protoborghesia (13).
Dalla zona tra basso Rodano e alto Danubio, a partire già
dal 700 circa a.C., principalmente per ragioni demografiche di sovrappopolamento, la loro espansione interessò le isole
britanniche (già raggiunte da una prima ondata precedente) e la
penisola iberica (Celtiberi)
e, successivamente, l'Italia settentrionale e i territori dei
Balcani, in cui vennero a contatto con l'impero di Alessandro Magno
e svolsero attività di mercenari, mentre una parte ritornò verso
l'Asia Minore (Galati) (14).
 Particolarmente
interessante è il fatto che la doppia migrazione verso l'odierna
Gran Bretagna mostra una nettissima evoluzione di questo popolo tra
900 e 500 a.C.: la prima ondata migratoria fu legata a popoli di
lingua gaelica, che, forse partiti dalla Spagna settentrionale,
approdarono in Irlanda, Scozia e Isola di Mann e svilupparono una
lingua denominata Celtico Q,
poiché al posto della lettera k
si utilizzava la lettera q;
la seconda migrazione fu caratterizzata da popoli britannici, che
partiti dal Belgio, in piena età lateniana, dunque nella massima
fase dello sviluppo socio-economico, colonizzarono Inghilterra,
Galles e Cornovaglia, sviluppando il Celtico
P, poiché la k era
sostituita da p (ad esempio,
cavallo, in indoeuropeo ekuos
divenne equos in gaelico e epos
in britanno). La mutazione consonantica q-p non fu che una delle
differenze tra le popolazioni delle due ondate: le prime vivevano in
fortificazioni, le seconde in villaggi ed è probabile che la
migrazione dei secondi spinse i primi verso zone più lontane (non a
caso il termine "gaelico"
deriva dalla parola "gwyddel"
che significa "selvaggi"
e fu attribuita, nella seconda migrazione, dai Gallesi agli avi
degli Irlandesi della prima migrazione) (15). Particolarmente
interessante è il fatto che la doppia migrazione verso l'odierna
Gran Bretagna mostra una nettissima evoluzione di questo popolo tra
900 e 500 a.C.: la prima ondata migratoria fu legata a popoli di
lingua gaelica, che, forse partiti dalla Spagna settentrionale,
approdarono in Irlanda, Scozia e Isola di Mann e svilupparono una
lingua denominata Celtico Q,
poiché al posto della lettera k
si utilizzava la lettera q;
la seconda migrazione fu caratterizzata da popoli britannici, che
partiti dal Belgio, in piena età lateniana, dunque nella massima
fase dello sviluppo socio-economico, colonizzarono Inghilterra,
Galles e Cornovaglia, sviluppando il Celtico
P, poiché la k era
sostituita da p (ad esempio,
cavallo, in indoeuropeo ekuos
divenne equos in gaelico e epos
in britanno). La mutazione consonantica q-p non fu che una delle
differenze tra le popolazioni delle due ondate: le prime vivevano in
fortificazioni, le seconde in villaggi ed è probabile che la
migrazione dei secondi spinse i primi verso zone più lontane (non a
caso il termine "gaelico"
deriva dalla parola "gwyddel"
che significa "selvaggi"
e fu attribuita, nella seconda migrazione, dai Gallesi agli avi
degli Irlandesi della prima migrazione) (15).
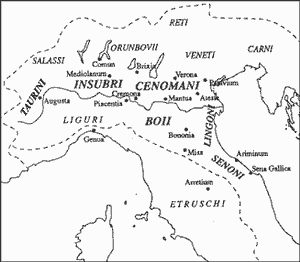 Per
quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza
tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,
probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi
archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni
misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli
ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi
di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e
forse anche di rapporti non sempre ostili. è
difficile definire
le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è
che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e
che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con
la loro collaborazione. Per
quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza
tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,
probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi
archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni
misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli
ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi
di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e
forse anche di rapporti non sempre ostili. è
difficile definire
le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è
che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e
che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con
la loro collaborazione.
I motivi che spinsero i Celti ad occupare l’Italia sono
anch’essi oscuri: forse furono attratti dalla fertilità e dal
clima mite del Meridione, o, più probabilmente, furono costretti
a spostarsi, come detto, a causa della pressione demografica unita
alla scarsità di terre coltivabili e ad altri problemi di
carattere politico e sociale. Verso l’inizio del IV secolo a. C.
i Celti - o Galli, secondo
la definizione latina - si stanziarono in Lombardia fino ai
confini con il Veneto, in Emilia (Anari e Boi), in Romagna (Lingoni)
e nelle Marche (Senoni), regioni praticamente sottratte agli
Etruschi e agli Umbri. La presa di Roma (390-386 a. C.) da parte
di Brenno (in realtà Brennan,
nome del dio della guerra, era assunto da ogni capotribù in
battaglia) fu vissuta, secondo le fonti antiche, come un evento
traumatico e fu probabilmente per questo che il fiero
popolo romano volle giustificare quella sconfitta con la ferocia
degli aggressori. Oggi, invece, si tende a considerare
l’invasione celtica non come quella di un’orda selvaggia, ma
piuttosto di una vasta comunità costretta a lasciare il proprio
territorio d’origine per problemi di sopravvivenza. E’
possibile che l'espansione sia poi proseguita verso sud-est senza
ulteriori grossi traumi (16).
Il IV secolo segna l'apogeo della grandezza delle tribù celtiche,
stanziate praticamente ovunque in Europa, come facilmente
visibile dando un'occhiata ad una cartina degli stanziamenti del
periodo.
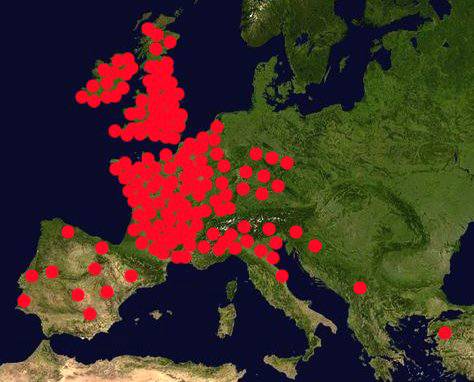
|
Tribù
Galliche stanziate in Europa nel periodo di Cesare:
Gallia
(attuale Belgio, Francia e Svizzera):
Allobrogi(Vienne); Ambiani (Amiens); Ambiliati;
Andecavi o Andi (Angers); Aquitani (Bordeaux);
Atrebati (Arras); Arverni (Auvergne); Aulerci
Eburovici (Normandia); Ausci (Aquitania); Baiocassi
(Bayeux, poi in Pannonia); Bellovaci (Beauvais);
Betasii; Bigerrioni(Aquitania); Biturigi (Bourges);
Boi (Aquitania, poi in Emilia Romagna, Pannonia e
Boemia); Carnuti (Chartres); Catalauni (Chalons);
Caturigi (valle dell'alta Durance); Cenomani (Le
Mans, poi in Lombardia e Veneto); Ceutroni (valli
dell'Isere e dell'Arc); Cocosati (Aquitania);
Coriosiliti (Corseul); Diablinti; Edui - Bibracte (Saone
et Loire); Elusati (Aquitania); Elvezi ( La Tene);
Garonni (Aquitania); Gati (Aquitania); Graioceli
(Moncenisio); Lemovici (Limoges); Lessovi
(Normandia); Leuci; Lingoni; Mandubi; Mediomatrici
(Metz); Meduli (Medoc); Meldi (Meaux); Menapi (Cassel);
Morini ( Boulogne-sur-Mer); Namneti (Nantes);
Nantuati (Martigny); Nervi (Bavay ); Osismi; Parisi
(Parigi); Petrocori (Périgord); Pictoni (Poitiers);
Ptiani (Aquitania); Redoni (Rennes); Remi (Reims);
Santoni (Saintes); Seduni (Martigny); Segusiavi
(Loira); Senoni (Orleans); Sequani (Besançon);
Sibuzati (Aquitania); Soziati (Aquitania); Suessioni
(Soissons); Tarbelli (Aquitania); Tarusati
(Aquitania); Tolosati (Tolosa); Treviri, Treveri (Trier);
Tricassi (Troyes); Tungri (Tongeren); Turoni (Tours);
Unelli (Normandia); Vangioni (Worms); Veliocassi (Rouen);
Vellavi (Ruessium); Veneti (Bretagna); Veragri (Martigny);
Viducassi (Vieux); Viromandui (Vermandois); Vocati
(Aquitania); Voconzi (Vaison-la-Romaine); Volci.
-
Inghilterra,
Irlanda, Scozia e Galles: Ancaliti (Hampshire
e Wiltshire, Inghilterra); Atecotti (Scozia o
Irlanda); Atrebati (Hampshire e Berkshire,
Inghilterra); Autini (Irlanda); Belgi (Wiltshire e
Hampshire, Inghilterra); Bibroci (Berkshire,
Inghilterra); Briganti (Inghilterra settentrionale);
Briganti (Irlanda); Cereni (Sutherland,
Inghilterra); Caledoni (Invernessshire, Scozia);
Cantiaci (Kent, Inghilterra); Carnonaci (Highland
scozzesi occidentali); Carvezi (Cumberland,
Inghilterra); Cassi (Inghilterra); Catuvellauni (Hertfordshire,
Inghilterra); Cauci (Irlanda); Corieltauvi (Leicestershire);
Coriondi (Irlanda); Corionotozi (Northumberland,
Inghilterra); Cornovi (Caithness, Inghilterra);
Cornovi (Cheshire, Inghilterra); Cornovi
(Cornovaglia, Inghilterra); Creoni (Argyllshire,
Scozia); Damnoni (Strathclyde, Inghilterra); Darini
(Irlanda); Deceangli (Flintshire); Decanzi (Ross
orientale, Inghilterra); Demezi (Dyfed, Galles);
Dobunni (Gloucestershire); Dumnoni (Devon,
Inghilterra); Durotrigi (Dorset, Inghilterra);
Eblani (Irlanda); Epidi (Kintyre, Inghilterra);
Gangani (Irlanda); Gangani (penisola di Lleyn);
Erpeditani (Irlanda); Iberni (Irlanda); Iceni (East
Anglia, Inghilterra); Lugi (Sutherland orientale,
Inghilterra); Magnazi (Irlanda); Manapi (Irlanda);
Novanzi (Galloway, Inghilterra); Ordovici (Gwynedd,
Galles); Parisi (East Riding, Inghilterra); Regnensi
(Sussex, Inghilterra); Robogdi (Irlanda); Segonziaci
(Inghilterra); Selgovi (bacino superiore del Tweed,
Inghilterra); Setanzi (Lancashire, Inghilterra);
Siluri (Gwent, Galles); Smerzi (Sutherland
meridionale, Inghilterra); Tassali (Aberdeenshire,
Scozia); Trinovanti (Essex, Inghilterra); Vacomagi (Banffshire,
Inghilterra); Velabri (Irlanda); Veniconi (Strathmore,
Inghilterra); Vennicni (Irlanda); Vodie (Irlanda);
Votadini (Lothian, Scozia).
-
Italia
settentrionale: Anari (Emilia); Boi (Emilia);
Carni (Carnia); Cenomani (Brescia); Anari (Oltrepò
Pavese); Graioceli (Moncenisio); Insubri
(Lombardia); Lingoni (Ferrara); Orobi (tra Como e
Bergamo); Salassi (Aosta e Canavese); Senoni (dalla
Romagna ad Ancona);Taurini (Torino); Vertamocori
(Novara)
-
Europa
centrale: Anartii (Ungheria); Arabiati (Illiria);
Boi (Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e
Germania); Cotini (Slovacchia); Eravisci (Ungheria);
Ercuniati (Illirico); Osii (Slovacchia); Scordisci
(Croazia, Serbia); Taurisci (Norico).
-
Spagna e
Portogallo: Arevaci; Asturi; Cantabri;
Carpetani; Celtiberi (Spagna); Cineti (Algarve,
Portogallo meridionale); Calleci (Portogallo e
Spagna); Lusitani (Portogallo); Vaccei; Vardulli.
-
Turchia:
Galati.
|
Come poté accadere, dunque, che un insieme
di popolazioni così vasto e, come vedremo meglio nella seconda
parte di questa breve ricognizione, così socialmente strutturato
sia sul piano delle relazioni interne che delle questioni
politico-economiche internazionali, potesse essere sconfitto da un
popolo molto più piccolo come quello romano?
La risposta a questa domanda risiede essenzialmente in due soli
concetti: unità e organizzazione militare.
 In
primo luogo, si è in precedenza detto che è assolutamente
scorretto parlare di un "popolo celtico": sia dai racconti
degli storici romani che dagli scarsi documenti scritti celtici
pervenutici (soprattutto da cronache irlandesi) risulta
assolutamente evidente (17)
che nessun celta, pur comprendendo di far parte di un vasto gruppo
etno-culturale, sentisse alcun legame verso il proprio macro-insieme
di popolazione. I vincoli di fedeltà erano, tuttalpiù, personali
verso un capotribù (con conseguente vincolo solo tribale), ma, in
larga parte, unicamente sentiti verso il proprio nucleo familiare
allargato, il clan. In
primo luogo, si è in precedenza detto che è assolutamente
scorretto parlare di un "popolo celtico": sia dai racconti
degli storici romani che dagli scarsi documenti scritti celtici
pervenutici (soprattutto da cronache irlandesi) risulta
assolutamente evidente (17)
che nessun celta, pur comprendendo di far parte di un vasto gruppo
etno-culturale, sentisse alcun legame verso il proprio macro-insieme
di popolazione. I vincoli di fedeltà erano, tuttalpiù, personali
verso un capotribù (con conseguente vincolo solo tribale), ma, in
larga parte, unicamente sentiti verso il proprio nucleo familiare
allargato, il clan.
È ovvio che, con queste premesse, fosse praticamente impossibile
per i celti organizzare alleanze estese in funzione antiromana: solo
in qualche caso, ad esempio contro Cesare, riuscirono ad organizzare
qualche forma di unione provvisoria e instabile tra tribù, ma
furono esperienze limitate sia nel numero che nel tempo, che
mancarono sempre della coesione necessaria ad affrontare una
organizzazione sociale come quella romana, che faceva del culto
patrio una sorta di religione di stato: la società dei Celti,
sebbene nell’ultimo periodo della sua storia fosse arrivata ad un
ragguardevole livello di organizzazione, purtroppo rimase sempre
prigioniera delle proprie divisioni interne. Fu principalmente
questo, e non la barbarie, l’ignoranza e l’arretratezza di un
popolo che non aveva nessuna di queste tre prerogative, a
determinare la loro sconfitta  da
parte dei Romani che ebbero la meglio prima sulle popolazioni
insediatesi in Italia Settentrionale (la cosiddetta Gallia
Cisalpina) e poi, con Cesare, anche su quelle che abitavano
l’Europa continentale (la Gallia Transalpina). All’epoca delle
guerre galliche, infatti, molte tribù non videro in Cesare l’
“invasore”, ma solo un altro potenziale alleato con il quale
stabilire eventuali intese. Così, anche di fronte ai Romani, le
tribù celtiche non trovarono una ragione di unione, ma si divisero
fra quelle che avevano deciso di sostenere Cesare e quelle che
invece avevano risolto di combatterlo. A parte la breve parentesi
della ribellione guidata da Vercingetorige, quindi, le varie
popolazioni celtiche non fecero mai causa comune. Fu questo il
motivo di base della caduta di quella civiltà che, se solo più
coalizzata, avrebbe potuto dominare su tutta l’Europa centrale (18). da
parte dei Romani che ebbero la meglio prima sulle popolazioni
insediatesi in Italia Settentrionale (la cosiddetta Gallia
Cisalpina) e poi, con Cesare, anche su quelle che abitavano
l’Europa continentale (la Gallia Transalpina). All’epoca delle
guerre galliche, infatti, molte tribù non videro in Cesare l’
“invasore”, ma solo un altro potenziale alleato con il quale
stabilire eventuali intese. Così, anche di fronte ai Romani, le
tribù celtiche non trovarono una ragione di unione, ma si divisero
fra quelle che avevano deciso di sostenere Cesare e quelle che
invece avevano risolto di combatterlo. A parte la breve parentesi
della ribellione guidata da Vercingetorige, quindi, le varie
popolazioni celtiche non fecero mai causa comune. Fu questo il
motivo di base della caduta di quella civiltà che, se solo più
coalizzata, avrebbe potuto dominare su tutta l’Europa centrale (18).
In secondo luogo (ma forse si potrebbe più
propriamente parlare di un semplice corollario della ragione sopra
accennata), forse proprio i punti di forza di quello che è oggi il
fascino peculiare dell'antico mondo celtico, la sua spiritualità e
la sua individualità sfrenata, furono gli elementi che portarono al
suo tramonto quando questo mondo entrò in contatto con la
disincantata civiltà romana, che viveva agli opposti concettuali:
alla spiritualità opponeva la prammatica praticità e
all'individualismo, l'arma più distruttrice e dominatrice mai
creata: il servizio militare con ferrea disciplina. L'
individualismo guerriero venne meno al confronto con la fredda e
calcolata strategia militare, nonostante i Celti fossero più
numerosi dei romani e impugnassero armi spaventosamente  più
micidiali. «Se vuoi sapere come i
Romani hanno conquistato il mondo conosciuto,» afferma il
grande scrittore fantasy ed esperto di strategie militari David
Gemmell (19), «la
risposta è il gladio, la corta spada che usavano. Una lama di 18
pollici con cui effettui affondi è diversa da una spada di tre
piedi con cui fai dei fendenti - questo significa che puoi stare
spalla a spalla su un muro, dove una lama calata di taglio ti
manterrebbe a sei piedi in ogni direzione dai tuoi compagni. Non
importa quanto i Celti superassero in numero i Romani, al momento
del contatto erano tre a uno per i Romani». più
micidiali. «Se vuoi sapere come i
Romani hanno conquistato il mondo conosciuto,» afferma il
grande scrittore fantasy ed esperto di strategie militari David
Gemmell (19), «la
risposta è il gladio, la corta spada che usavano. Una lama di 18
pollici con cui effettui affondi è diversa da una spada di tre
piedi con cui fai dei fendenti - questo significa che puoi stare
spalla a spalla su un muro, dove una lama calata di taglio ti
manterrebbe a sei piedi in ogni direzione dai tuoi compagni. Non
importa quanto i Celti superassero in numero i Romani, al momento
del contatto erano tre a uno per i Romani».
Così, dunque, la più grande civiltà dell'età del ferro, con la
sola eccezione di Scozia e Irlanda, venne sottomessa, inglobata
nell'Impero, colonizzata e romanizzata, snaturandosi e finendo per
"scomparire" per oltre 2000 anni.
Note:
(1) Caio Giulio Cesare, De
Bello Gallico, passim..
(2) Strabone, Geografia,
libri III, IV, VI , VII.
(3) Tito Livio, Storia
di Roma, libro V.
(4) Cassio Dione Cocceiano, Storia
di Roma, libri LI-LIV.
(5) C. Renfrew, Archeology
and Language - the Puzzle of IndoEuropean Origins, Penguin,
Londra 1989, pp. 208 ss.
(6) Ad esempio, J. Layard, I
Celti - alle radici di un inconscio europeo, Xenia, Milano
1995, pp. 28-42.
(7)
Ad esempio, L. Melis, Shardana
- I Popoli del Mare, CDE, Cagliari 2002, passim e L. Sudbury, Hanebu.
I Popoli Perduti che Crearono il Mediterraneo, in Hera, dicembre
2007.
(8) P. Berresford Ellis, The
Celts, Carroll & Graf, Manchester 2003, passim.
(9) Ad esempio, B.
Cunliffe, The Ancient Celts, Penguin, London 2000, pp. 36-48.
(10) L. Sudbury, BarBar
o «della genericità»,
www.storiamedievale.net, gennaio 2008.
(11) Tra gli altri, B.
McEvoy, M. Richards, P. Forster, D. G. Bradley, The
Longue Durée of Genetic Ancestry: Multiple Genetic Marker Systems and
Celtic Origins on the Atlantic Facade of Europe, in The
American Journal of Human Genetics, ottobre 2004.
(12) B. Cunliffe, The
Oxford Illustrated Prehistory of Europe, Oxford O.U.P, 1994, pp.
250-254.
(13) J.Collis, The
Celts: Origins, Myths, Invention, Tempus, London 2003, passim.
(14) P. Berresford Ellis, The
Celts cit., pp. 112-141.
(15) J. Carey, J.T. Koch, The
Celtic Heroic Age: Literary Sources for Ancient Celtic Europe &
Early Ireland & Wales, David Brown Book Company, Cardiff
2003, pp. 81.
(16) J. De Galibier, L'epopea
dei Celti. Storia e Mistero, Keltia, Aosta 1998, passim e www.celticanapoletana.org.
(17) Un'ampia sintesi è
rinvenibile in J. Carey, J.T. Koch, The
Celtic Heroic Age: Literary Sources for Ancient Celtic Europe &
Early Ireland & Wales cit., passim.
(18) C.Nicolet,
Rome et la Conquête du Monde Méditerranéen, tomo I, PUF,
Parigi 2001, pp. 409 ss. e www.signainferre.it.
(19) Citato in F. Truppi, La
riscoperta di una civiltà, in www.celticworld.it.
|

 Secondo
un'altra teoria (8), ben più
accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:
i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del
Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine
indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una
migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero
entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si
sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale
(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).
La coda di questa migrazione
orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,
si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in
seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti
Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,
erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )
ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte
usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,
ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico
a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi
sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli.
Secondo
un'altra teoria (8), ben più
accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:
i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del
Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine
indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una
migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero
entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si
sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale
(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).
La coda di questa migrazione
orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,
si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in
seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti
Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,
erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )
ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte
usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,
ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico
a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi
sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli. Due
teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno
conto della origine primaria della razza. Una terza
ipotesi (9), basata su studi etno-storici e
recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove
accennato (10), alcuni studiosi (11),
basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente
quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una
sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato
una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro
passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,
nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a
inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)
occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e
ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta).
Due
teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno
conto della origine primaria della razza. Una terza
ipotesi (9), basata su studi etno-storici e
recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove
accennato (10), alcuni studiosi (11),
basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente
quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una
sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato
una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro
passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,
nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a
inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)
occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e
ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta).
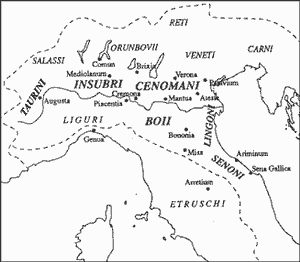 Per
quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza
tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,
probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi
archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni
misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli
ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi
di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e
forse anche di rapporti non sempre ostili. è
difficile definire
le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è
che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e
che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con
la loro collaborazione.
Per
quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza
tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,
probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi
archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni
misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli
ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi
di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e
forse anche di rapporti non sempre ostili. è
difficile definire
le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è
che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e
che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con
la loro collaborazione.