 Mentre
il califfato Abbaside si stava a poco a poco sgretolando, a
oriente un nuovo califfato scita stavo sorgendo: quello fatimide,
che, al massimo della sua estensione, arrivò a coprire una vasta
area del mondo arabo, dal Mar Rosso a est all'Oceano Atlantico a
ovest. Originariamente con sede in Tunisia, la dinastia dei
Fatimidi estese il suo dominio su tutta la costa mediterranea
dell'Africa, fino all'Egitto, che divenne il centro del
califfato con la costruzione della città del Cairo nel 969. Mentre
il califfato Abbaside si stava a poco a poco sgretolando, a
oriente un nuovo califfato scita stavo sorgendo: quello fatimide,
che, al massimo della sua estensione, arrivò a coprire una vasta
area del mondo arabo, dal Mar Rosso a est all'Oceano Atlantico a
ovest. Originariamente con sede in Tunisia, la dinastia dei
Fatimidi estese il suo dominio su tutta la costa mediterranea
dell'Africa, fino all'Egitto, che divenne il centro del
califfato con la costruzione della città del Cairo nel 969.La classe dirigente dello Stato apparteneva al ramo dello scitismo ismailita e i capi della dinastia erano anche imam, avendo, quindi, anche tutto il 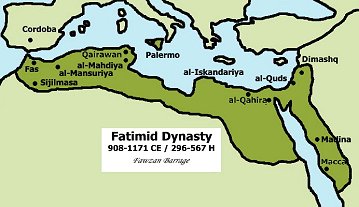 potere
religioso e facendo, per altro, parte della catena dei titolari
della carica di Califfo come discendenti di Ali (da cui il nome
fatimide, che si riferiva alla moglie di Ali, Fatima). potere
religioso e facendo, per altro, parte della catena dei titolari
della carica di Califfo come discendenti di Ali (da cui il nome
fatimide, che si riferiva alla moglie di Ali, Fatima).Il califfato fatimide, comunque, rappresentò uno dei periodi di maggiore tolleranza religiosa nei confronti dei non-Ismailiti dell'Islam, nonché nei confronti degli ebrei, cristiani, maltesi e cristiani copti che facevano parte del regno, al punto che gran parte dei giudici delle zone Fatimidi risultano essere stati studiosi Hanafi sunniti, più adatti a comprendere una popolazione prevalentemente sunnita e che un ruolo preminente nello sviluppo dello stato venne esercitato dalle popolazioni berbere. Storicamente il califfato durò dal 909 al 1171, quando Saladino divenne sultano d'Egitto e formalmente fece tornare il paese ad una fedeltà nominale verso il califfato sunnita abbaside.
All'inizio della sua esistenza,
dunque, il potere dell'impero si basava soprattutto sui Kutama
berberi e sulla loro forza militare, grazie alla quale si
riuscirono ad occupare vaste aree del Nord Africa, della
Palestina, della Siria e, per un breve periodo, persino Baghdad.
In poco tempo, così, il controllo di Abdullah al-Mahdi si estese
su tutto il centro del Maghreb, in un'area comprendente gli
odierni Marocco, Algeria, Tunisia e Libia [1].
Con Al-Muizz Lideenillah, poi, i Fatimidi, verso la fine del X
secolo, penetrarono anche in Egitto abbattendo la dinastia
Ikhshidide e fondando una nuova capitale a al-Qahira (Cairo) nel
969, che venne progettata come una residenza reale per il
califfo fatimide e il suo esercito sebbene l'effettiva capitale
amministrativa ed economica dell'Egitto rimanesse nella città di
Fustat fino al 1169 [2].
Dopo l'Egitto, i Fatimidi continuarono a conquistare le zone
circostanti fino a quando ebbero il pieno controllo di un'area
vastissima che comprendeva persino la Siria e la Sicilia.
Fu, probabilmente, proprio
questo l'errore maggiore di una dinastia che, per altri
versi, si dimostrò di estrema lungimiranza: a differenza
di altri governi della zona, ad esempio, i Fatimidi
basavano la carriera negli uffici statali più sul merito
che sulla casata o la fede, cosicché i membri di altre
branche dell'Islam, come i sunniti, avevano le stesse
probabilità di essere nominati a incarichi di governo
che gli sciiti e la tolleranza era estesa anche ai non
musulmani, come i cristiani e gli ebrei, che arrivarono
ad occupare alti livelli di governo grazie alle loro
capacità, anche se vi furono, in alcuni casi, eccezioni
a questo generale atteggiamento di tolleranza, in
particolare sotto Al-Hakim bi-Amr Allah, che, a quanto
risulta dalle cronache medievali, arrivò a organizzare
vere e proprie crociate contro i drusi [3].
 Mentre
l'esercito combatteva con successo sui campi di
battaglia, però, le divisioni etniche cominciarono ad
avere effetti negativi sulla politica interna del
califfato in cui, tradizionalmente, l'elemento berbero
dell'esercito esercitava una forte influenza sugli
affari di stato: quando l'elemento turco cominciò a
divenire sempre più potente i due gruppi etnici
entrarono in contrasto e, verso il 1020, gravi disordini
ebbero luogo anche tra le truppe dei neri africani. Mentre
l'esercito combatteva con successo sui campi di
battaglia, però, le divisioni etniche cominciarono ad
avere effetti negativi sulla politica interna del
califfato in cui, tradizionalmente, l'elemento berbero
dell'esercito esercitava una forte influenza sugli
affari di stato: quando l'elemento turco cominciò a
divenire sempre più potente i due gruppi etnici
entrarono in contrasto e, verso il 1020, gravi disordini
ebbero luogo anche tra le truppe dei neri africani.Intorno al 1060, la saldatura provvisorio tra i diversi gruppi etnici all'interno dell'esercito fatimide si sgretolò, mentre l'Egitto veniva colpito da un periodo di grave siccità e carestia. Le risorse in declino accelerarono l'evolversi dei problemi tra le diverse fazioni e iniziò una vera e propria guerra civile, in un primo momento tra i turchi e le truppe africane, che cominciarono a combattersi mentre i berberi spostavano la loro alleanza tra le due parti. Le forze turche dell'esercito fatimide finirono per occupare il Cairo e tenere il califfo in loro potere mentre le rimanenti truppe berbere e le forze sudanesi si davano al saccheggio di altre parti d'Egitto, rendendo la situazione ancora peggiore. Nel 1072 il califfo fatimide Abu Tamim Ma'ad al-Mustansir Billah, nel disperato tentativo di salvare l'Egitto, chiese aiuto al generale Badr al-Jamali, che era al momento governatore di Acri, in Palestina. Badr al-Jamali condusse le sue truppe in Egitto e riuscì a sopprimere con successo i diversi gruppi di eserciti ribelli, in gran parte turchi ma, anche se il califfato venne salvato dalla distruzione immediata, la ribellione decennale aveva devastato l'Egitto, che non riuscì per lungo tempo a risollevarsi. A seguito del suo aiuto, Badr al-Jamali  venne nominato visir del califfo fatimide, diventando il
primo dei visir militari che dominarono la politica del
tardo califfato fatimide, risultando i veri capi di
stato mentre il califfo era ridotto al ruolo di una
mera figura rappresentativa [7].
venne nominato visir del califfo fatimide, diventando il
primo dei visir militari che dominarono la politica del
tardo califfato fatimide, risultando i veri capi di
stato mentre il califfo era ridotto al ruolo di una
mera figura rappresentativa [7].Nel frattempo, già a partire dal 1040, molti "Zirid" berberi (governatori del Nord Africa sotto i Fatimidi) avevano dichiarato la loro indipendenza dai Fatimidi e chiesto il loro riconoscimento da parte dei califfi abbasidi Baghdad e dopo il 1070 i possessi fatimide sulla costa Levante furono erosi prima dalle invasioni turche e poi dalle Crociate, cosicché il territorio del califfato si ridusse fino a consistere nel solo Egitto. Infine, mentre il sistema politico fatimide era già in piena decadenza e i generali delle aree periferiche erano praticamente indipendenti, nel 1169, Nur ad-Din inviò il generale Shirkuh a prendere in ostaggio l'ultimo visir fatimide, Shawar: quando due mesi dopo aver conquistato il Cairo, Shirkuh morì il comando passò a suo nipote, Saladino, che diede inizio al Sultanato ayyubide di Egitto e Siria [8]. NOTE:
(1) P.E. Walker,
Fatimid
History and Ismaili Doctrine, Ashgate
2008, pp. 96 ss.
(2) M. Rodenbeck, Cairo: The City Victorious, Vintage 2000, pp. 38-81 passim. (3) S. Falah, The Druze in the Middle East, Druze Research & Publications Institute 2002, pp. 78 ss. (4) J.M. Bloom, Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt, Yale University Press 2008, passim. (5) H. Halm, The Fatimids and Their Traditions of Learning, I. B. Tauris 2001, passim. (6) H. Haji, Founding the Fatimid State: The Rise of an Early Islamic Empire, I. B. Tauris 2006, pp. 2011 ss. (7) L.S. Al-Imad, The Fatimid vizierate, 969-1172,K. Schwarz 1990, pp. 163 ss. (8) D. Robinson, Muslim Societies in African History, Cambridge University Press 2004, pp. 183 ss. |
 Lo
stato fatimide nacque all'interno del popolo Kutama
dell'Algeria. La dinastia fu fondata nel 909 da Abdullah
al-Mahdi Billah ma la sua nascita fu conseguenza dell'opera del
suo più grande missionario e sostenitore Abu 'Abdullah al-Shi'a,
che nel 892 aveva dato vita ad un movimento di islamizzazione
tra i berberi Kutama ed è riuscito a convertirli all'Islam
sciita. Al-Shi'a aveva iniziato la sua predicazione dopo aver
incontrato un gruppo di berberi durante un pellegrinaggio:
questi uomini si vantavano del fatto che il paese dei Kutama,
nella Ifriqiya occidentale (oggi parte dell'Algeria), non si
fosse mai sottomesso al governo Aghlabide e, Al-Shi'a decise di
recarsi nella regione, dove iniziò a predicare la dottrina
ismailita. I contadini berberi, che erano stati oppressi per
decenni dal governo corrotto Aghlabide, ben presto dimostrarono
di essere una base perfetta per una futura sedizione: Al-Shi'a
iniziò, così, a conquistare molte città della regione: prima
Mila, poi Sétif, Kairouan e alla fine Raqqada, la capitale
aghlabide. Nel frattempo, Ubayd Allah al-Mahdi era stato
imprigionato a Sijilmasa a causa delle sue convinzioni ismailite
e, dunque, nel 909, Al-Shi'a inviò una grande forza di
spedizione per salvare al-Mahdi, il quale, liberato, divenne il
capo incontrastato del nuovo stato che si stava formando,
potendo far leva sulla sua discendenza diretta da Maometto
attraverso la figlia Fatima
Lo
stato fatimide nacque all'interno del popolo Kutama
dell'Algeria. La dinastia fu fondata nel 909 da Abdullah
al-Mahdi Billah ma la sua nascita fu conseguenza dell'opera del
suo più grande missionario e sostenitore Abu 'Abdullah al-Shi'a,
che nel 892 aveva dato vita ad un movimento di islamizzazione
tra i berberi Kutama ed è riuscito a convertirli all'Islam
sciita. Al-Shi'a aveva iniziato la sua predicazione dopo aver
incontrato un gruppo di berberi durante un pellegrinaggio:
questi uomini si vantavano del fatto che il paese dei Kutama,
nella Ifriqiya occidentale (oggi parte dell'Algeria), non si
fosse mai sottomesso al governo Aghlabide e, Al-Shi'a decise di
recarsi nella regione, dove iniziò a predicare la dottrina
ismailita. I contadini berberi, che erano stati oppressi per
decenni dal governo corrotto Aghlabide, ben presto dimostrarono
di essere una base perfetta per una futura sedizione: Al-Shi'a
iniziò, così, a conquistare molte città della regione: prima
Mila, poi Sétif, Kairouan e alla fine Raqqada, la capitale
aghlabide. Nel frattempo, Ubayd Allah al-Mahdi era stato
imprigionato a Sijilmasa a causa delle sue convinzioni ismailite
e, dunque, nel 909, Al-Shi'a inviò una grande forza di
spedizione per salvare al-Mahdi, il quale, liberato, divenne il
capo incontrastato del nuovo stato che si stava formando,
potendo far leva sulla sua discendenza diretta da Maometto
attraverso la figlia Fatima
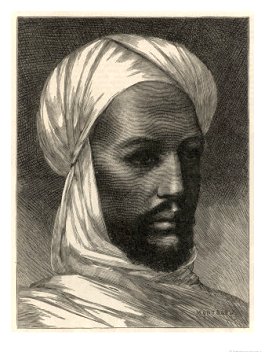 az-Zahra
e il di lei marito Alī ibn-abi-Talib, il primo imam sciita.
az-Zahra
e il di lei marito Alī ibn-abi-Talib, il primo imam sciita. 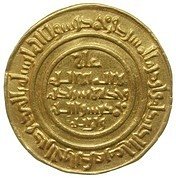 L'attenzione
fatimide per il commercio a lunga distanza fu, però,
accompagnata da una mancanza di interesse per
l'agricoltura e da un abbandono del sistema di
irrigazione del Nilo, cosa che ebbe, a lungo termine,
dure conseguenze.
L'attenzione
fatimide per il commercio a lunga distanza fu, però,
accompagnata da una mancanza di interesse per
l'agricoltura e da un abbandono del sistema di
irrigazione del Nilo, cosa che ebbe, a lungo termine,
dure conseguenze. 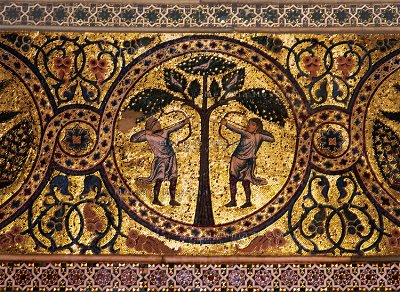 Al
di là di queste eccezioni, i Fatimidi furono anche noti
come grandi mecenati e protettori delle arti e se il
picco più alto dello sviluppo figurativo si ebbe nel
campo della lavorazione della ceramica, del vetro e dei
metalli, molte tracce di architettura fatimida sono
ancora oggi rinvenibili al Cairo, con edifici splendidi
quali Al Azhar, la prima università dell'Oriente e
forse la più antica della storia, fondata come moschea
del comandante fatimide Jawhar agli ordini del califfo
Al-Muizz e poi sempre più importante come centro di
studi, fino a diventare il cuore dello sviluppo
giuridico islamico, e la moschea di Al Hakim [
Al
di là di queste eccezioni, i Fatimidi furono anche noti
come grandi mecenati e protettori delle arti e se il
picco più alto dello sviluppo figurativo si ebbe nel
campo della lavorazione della ceramica, del vetro e dei
metalli, molte tracce di architettura fatimida sono
ancora oggi rinvenibili al Cairo, con edifici splendidi
quali Al Azhar, la prima università dell'Oriente e
forse la più antica della storia, fondata come moschea
del comandante fatimide Jawhar agli ordini del califfo
Al-Muizz e poi sempre più importante come centro di
studi, fino a diventare il cuore dello sviluppo
giuridico islamico, e la moschea di Al Hakim [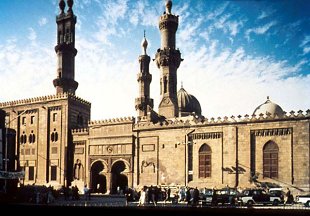 agli
studenti esentandoli da numerose forme di tassazione.
agli
studenti esentandoli da numerose forme di tassazione. dell'Egitto,
si cominciarono ad incorporare anche forze locali (che,
comunque, rimasero una parte relativamente piccola del
fronte militare) e, soprattutto, un cambiamento
fondamentale si verificò quando il califfo fatimide
cercò di spingersi in Siria nella seconda metà del X
secolo. Qui, infatti, i Fatimidi si trovarono di fronte
alle forze turche del califfo abbaside e cominciarono a
realizzare i limiti della loro struttura bellica,
cosicché, nel corso dei regni di Abu Mansur
dell'Egitto,
si cominciarono ad incorporare anche forze locali (che,
comunque, rimasero una parte relativamente piccola del
fronte militare) e, soprattutto, un cambiamento
fondamentale si verificò quando il califfo fatimide
cercò di spingersi in Siria nella seconda metà del X
secolo. Qui, infatti, i Fatimidi si trovarono di fronte
alle forze turche del califfo abbaside e cominciarono a
realizzare i limiti della loro struttura bellica,
cosicché, nel corso dei regni di Abu Mansur
 Nizar
al-Aziz Billah e Al-Hakim bi-Amr Allah, i califfi
iniziarono ad integrare plotoni turchi e successivamente
neri africani (più tardi anche altri gruppi, come gli
armeni, vennero impiegati). Le unità dell'esercito erano
generalmente separate secondo caratteristiche etniche: i
berberi erano di solito l'avanguardia della cavalleria e
i fanti leggeri, mentre i turchi erano gli arcieri a
cavallo o la cavalleria pesante (nota come "i
mamelucchi") e gli africani neri, i siriani e gli arabi
in generale agivano come la fanteria pesante e arcieri a
piedi. Questo sistema basato sulla separazione etnica
dell'esercito, insieme con lo stato di schiavitù
parziale di molti dei combattenti, sarebbe rimasto
sostanzialmente immutato per molti secoli in Egitto
anche dopo la caduta del califfato fatimide.
Quest'ultimo, comunque, mise tutta la sua forza militare
al servizio del mondo islamico e alla sua difesa ogni
volta che esso risultò minacciato, in particolare
quando, sotto il regno di Al-Muizz Lideenillah,
l'Impero bizantino, governato da Niceforo, si scontrò
con i musulmani a Creta nel 961. Niceforo voleva
ricostituire l'Impero romano d'Oriente di Costantino e
la realizzazione dei suoi propositi sembrava facilitata
dal fatto che i governanti musulmani combattessero tra
di loro, tanto che l'imperatore riuscì a spingersi molto
addentro alla Siria, fino ai confini dell'Iraq
settentrionale ma furono proprio l'esercito e la marina
dei Fatimidi a fermare la sua avanzata e a riconquistare
i territori perduti [
Nizar
al-Aziz Billah e Al-Hakim bi-Amr Allah, i califfi
iniziarono ad integrare plotoni turchi e successivamente
neri africani (più tardi anche altri gruppi, come gli
armeni, vennero impiegati). Le unità dell'esercito erano
generalmente separate secondo caratteristiche etniche: i
berberi erano di solito l'avanguardia della cavalleria e
i fanti leggeri, mentre i turchi erano gli arcieri a
cavallo o la cavalleria pesante (nota come "i
mamelucchi") e gli africani neri, i siriani e gli arabi
in generale agivano come la fanteria pesante e arcieri a
piedi. Questo sistema basato sulla separazione etnica
dell'esercito, insieme con lo stato di schiavitù
parziale di molti dei combattenti, sarebbe rimasto
sostanzialmente immutato per molti secoli in Egitto
anche dopo la caduta del califfato fatimide.
Quest'ultimo, comunque, mise tutta la sua forza militare
al servizio del mondo islamico e alla sua difesa ogni
volta che esso risultò minacciato, in particolare
quando, sotto il regno di Al-Muizz Lideenillah,
l'Impero bizantino, governato da Niceforo, si scontrò
con i musulmani a Creta nel 961. Niceforo voleva
ricostituire l'Impero romano d'Oriente di Costantino e
la realizzazione dei suoi propositi sembrava facilitata
dal fatto che i governanti musulmani combattessero tra
di loro, tanto che l'imperatore riuscì a spingersi molto
addentro alla Siria, fino ai confini dell'Iraq
settentrionale ma furono proprio l'esercito e la marina
dei Fatimidi a fermare la sua avanzata e a riconquistare
i territori perduti [